Iron Maiden ranked: storia di una classifica degli album
La prima melodia maideniana a travolgermi fu una rullata tribale di Clive Burr, seguita dagli arpeggi delle chitarre gemelle di Smith e Murray: quella era Another Life, quarta traccia dell’album Killers; ma per me era una canzone di un gruppo sconosciuto inserita in una compilation di un amico. Il top del rock anni ’80 in una cassetta da 90 minuti, come si ascoltava la musica quando ero ragazzino io. In quell’estate del 1989 quel pezzo rotolava nel mangianastri almeno due o tre volte al giorno; l’attacco vocale “as I lay here lying on my bed / sweet voices coming to me“, me lo sentivo sdraiato sul letto, e quella voce punk mi arrivava addosso come un incantesimo: una seduzione estrema verso una musica, l’heavy metal, considerata la via della perdizione. Solo tempo dopo avrei scoperto che quella voce era di Paul Di Anno, primo cantante degli Iron Maiden; e che la parte strumentale della canzone era in realtà un’altra traccia, sempre di Killers: quella Genghis Khan che partiva trafiggendomi come un arpione elettrico, ma che a metà, con un cambio di ritmo sognante, mi risucchiava come il canto di una sirena. Mi ero già perdutamente innamorato; come da adolescente puoi perdere la testa per la ragazza che incroci a scuola, e di cui non conosci nemmeno il nome.

E’ proprio a scuola che fra compagni e amici comincia a circolare il nome di questa band: ma come? Ti piacciono gli AC/DC e i Deep Purple, e non conosci gli Iron Maiden? Ma non saranno troppo pesanti per me? Chiedevo un po’ intimorito. Alla fine mi lasciai tentare: noleggiai The Number of The Beast, la cui fama di album satanista lo precedeva un po’ dappertutto (e in realtà nella title track il protagonista li vuole “denunciare alle forze dell’ordine questi riti“); e presi anche Seventh Son of a Seventh Son, l’album con la cover di Eddie – la mascotte degli Iron Maiden – sospeso sulle acque artiche, tra fuochi fatui e iceberg a forma di zombie. E cominciai l’educazione maideniana proprio dal CD del “Settimo figlio”:
“Seven deadly sins / Seven ways to win / Seven holy paths to hell / And your trip begins – Sette peccati capitali / Sette vie per vincere / Sette sentieri sacri per l’inferno / Ecco che il tuo viaggio comincia.”
Iniziava così, con l’inquieta voce di Bruce Dickinson, e una chitarra acustica; poi si scatenò il maremoto, con le concentriche onde di chitarra synth, il muro sonoro della batteria di Nicko McBrain, i vorticosi riff di Dave Murray e Adrian Smith, e il cavalcante basso di Steve Harris: era Moonchild che mi schiudeva la bellezza di una musica complessa eppure immediata.
E quello era davvero l’inizio del viaggio, dentro a un sogno infinito; una storia d’amore tra me e uno dei gruppi metal più acclamati di sempre. Perchè gli Iron Maiden sono idolatrati da milioni di persone in tutto il mondo, attraversando generazioni lontane ed estrazioni diverse: ragazzi e ragazze, donne e uomini che si perdono dietro agli assoli selvaggi, l’ipnotica e tonante ritmica di basso e batteria, la voce che ti fa volare nelle lande dell’immaginazione. Uno dei lati affascinanti degli Iron Maiden sono le liriche: spesso ispirate a opere letterarie e grandi scrittori, parlano di personaggi mitologici o fatti storici che segnano l’umanità; rime che raccontano di religioni, paradisi e inferni, e pratiche esoteriche; narrazioni di guerre vicine o lontane nel tempo, sempre con un deciso stampo anti-militarista; fanno rivivere grandi esplorazioni e violente colonizzazioni; descrivono leggende oscure e maledette, epopee futuristiche e mondi criminali; affrontano problematiche sociali e perfino introspezioni intimiste.
La discografia di questo quarantennale gruppo è un ininterrotto flusso metaforico che plana tra il bene e il male, il giusto e lo sbagliato, l’oppressione e la libertà, il rimpianto e la speranza, il coraggio e la follia, la morte e l’aggrapparsi alla vita. I testi degli Iron, presi singolarmente, spesso possono essere recitati come veri e propri poemi; ma incordati nel pentagramma maideniano, ti scatenano vividi colori davanti agli occhi, visioni danzanti, facendoti fluttuare sulle emozioni. Sono canzoni che diventano colonna sonora di una vita intera. Sicuramente della mia, di quella parte di me metallara che in fondo, dall’adolescenza e periodicamente, si è sempre tuffata nel gorgo musicale della band inglese. Tanti sono i ricordi legati agli Iron Maiden: i ritrovi dagli amici con lo stereo a palla; la prima canzone richiesta a una radio; le feste scolastiche, i primi baci; la fuga dai nonni in Lunigiana per riuscire a vederli a Reggio Emilia dopo un esame di riparazione disastroso; la prima guida in autostrada per andare a vederli a Milano; il primo disco messo in radio quando un amico mi invitò a co-condurre il suo programma.
Dico tuffi periodici, perché ci sono stati anni in cui gli Iron Maiden li ho tralasciati: certo, per coltivare altri generi – adorando praticamente tutto il mare magnum della musica; ma la realtà è un’altra: l’abbandono del cantante Bruce Dickinson nel 1993, per perseguire una carriera da solista, fu un brutto colpo. Il frontman, l’uomo che tiene in pugno migliaia di fan come un funambolico direttore d’orchestra, lasciò un vuoto incolmabile su quel palco, attorno a quel microfono. La scelta poi di ingaggiare Blaze Bayley, un timbro vocale completamente diverso rispetto a quello di Dickinson, mi pareva un tradimento. L’uscita di The X Factor non fece che confermare quel sentimento; e doveva essere abbastanza condiviso, visto che nella seconda metà degli anni ’90 la stella degli Iron Maiden brillava sempre meno. Fino al punto in cui la stessa esistenza della band non era più così scontata.
Finalmente arrivò l’ammissione da parte di Steve Harris, fondatore e un po’ padre padrone degli Iron Maiden, che qualcosa si era rotto; ma non ancora in modo irreparabile. Bruce Dickinson, che intanto mieteva successi, venne richiamato, e convinto a rientrare con la promessa di una nuova direzione musicale, più condivisa. E con lui venne imbarcato nell’avventura anche Adrian Smith, il geniale chitarrista che aveva lasciato gli Iron nel 1990 perché in contrasto con la linea di Harris.
La vecchia banda, quella dell’epoca d’oro – da Piece of Mind a Seventh Son of a Seventh Son, passando per Powerslave e Somewhere in Time – si era riformata. Restava anche Janick Gers, il sostituto di Smith; e che ora andava a comporre insieme a lui e Murray uno sfolgorante trio di chitarre.
Era il 1999 quando venne annunciato il tour dei Maiden con Dickinson e Smith. Mi catapultai al forum di Assago, in quel settembre di fine millennio: per crederci davvero, dovevo vederli con i miei occhi. Ed erano lì, sudati e capelloni, a saltare sul palco come ragazzini, a spaccare la serata con classici come Aces High, Phantom of the Opera, The Evil That Men Do, Hallowed Be Thy Name.
Quell’impazzimento, tuttavia, si smorzò l’anno dopo con l’uscita del nuovo album, Brave New World. L’ascolto fu pieno di attese e intransigente: una volta constatato di non avere tra le mani una riedizione dei successi degli anni d’oro, mi convinsi che gli Iron Maiden di cui mi ero follemente innamorato non esistevano più. Per il successivo album, Dance of Death, mi bastò il giudizio di alcuni amici: non ne vale la pena.
Fu così che non ascoltai nemmeno la prima canzone dell’album, Wildest Dreams; un pezzo in cui gli Iron Maiden lo urlavano che loro per primi non volevano crogiolarsi nel passato: si concentravano sulla strada presente e guardavano al futuro:
“When I’m feeling down and low / I vow I’ll never be the same again / I just remember what I am / And visualize just what I’m gonna be – Quando mi sento giù di morale / mi riprometto che non sarò più lo stesso / Mi ricordo di quello che sono / e visualizzo solo quello che vorrò essere.”
Gli Iron Maiden avevano accettato lo scorrere del tempo: la naturale evoluzione dei loro gusti musicali, e delle loro capacità compositive; e nel caso di Dickinson, il confrontarsi con un timbro vocale non più etereo, ma mortale. Ero io quello stratificato in un’epoca irripetibile della band inglese. Ed è così che sulla mia mappa musicale, l’uscita di A Matter of Life and Death, album del 2006, non venne nemmeno registrata.
Dall’inizio del millennio ho sempre riascoltato gli album degli anni ’80; e perfino No Prayer for the Dying e Fear of the Dark, i lavori degli anni ’90 con Dickinson alla voce, visti come l’inizio del declino rispetto all’epoca d’oro.
Quando nel 2010 gli Iron Maiden pubblicarono The Final Frontier, decisi di concedergli una possibilità: e lo ascoltai varie volte su YouTube, arrivando a definirlo un album orecchiabile e godibile. Tuttavia era ancora troppo forte la tentazione di paragonarlo con i capolavori del glorioso passato; ed era sempre lì che finivo: irrimediabilmente sazio di ascoltare le mie canzoni preferite.
Con la stessa supponenza nel 2015 accolsi l’uscita di The Book of Souls, a cui gli dedicai un veloce ascolto. Però qualcosa cambiò, forse grazie all’eco delle buone recensioni dell’ultima opera: il sentimento prevalente era la stima verso un gruppo di ultracinquantenni che credeva, nonostante tutto, al proprio lavoro e alla propria musica.
Nel 2016, in un periodo che definirei una seconda stagione d’amore per gli Iron Maiden, ho ripreso ad ascoltarli; ma con un’attitudine diversa: ho imparato ad apprezzarne le canzoni rivisitandole con la maturità di un quarantenne; ritrovandomi con chiavi di lettura che magari da giovane mi sfuggivano. Ecco che la discografia della mia band preferita luccicava di un’aurea nuova; e mi sembrava incredibile, ma gli Iron Maiden mi piacevano ancora di più. E’ stato allora che la verità, inconsciamente nascosta per tutto quel tempo, si è affacciata: della mia band preferita c’erano album che non avevo mai nemmeno ascoltato; e altri che avevo relegato troppo in fretta nel dimenticatoio. Perché non dargli una vera chance?

Stavolta, però, mi sono dato una regola: non fare paragoni con i mostri sacri dell’epoca d’oro; ma ascoltare buona musica, se suonando quegli album la riconoscevo come tale.
La seduzione dei “nuovi” Iron Maiden è stata lenta, con brusche interruzioni; la complessità di alcuni pezzi, inseriti in opere spesso concettuali, merita una recezione che vada oltre l’immediata orecchiabilità. Alcuni album hanno richiesto uno sforzo per capire quello che Harris e soci avevano da “dire”.
Quando finalmente il messaggio è arrivato a destinazione, quella stessa musica che fino a poco prima non mi entusiasmava, all’improvviso mi faceva sbarrare gli occhi; e balbettare parole come “fantastico”, “bellissimo”, incredibile”. Per me è stata come la scoperta di un Nuovo Mondo: un continente inesplorato disseminato di splendide melodie e liriche preziose. Con la conseguenza che l’ordine stesso delle cose si è ribaltato, portandomi a dubitare di alcune certezze che credevo scolpite nella roccia.
Scorrendo varie classifiche degli album, per trovare conferme che le mie sensazioni non fossero eresie, ho scoperto di non essere solo: molti condividono i giudizi positivi sui lavori del nuovo millennio; e perfino sugli album con Blaze alla voce.
E’ così che sono giunto a una mia classifica dell’intera discografia degli Iron Maiden: dall’album che meno preferisco, a quelli che considero dei capolavori. Un risultato costruito principalmente sui miei gusti; e su un giudizio personale imperniato sull’ascolto e non certo su conoscenze tecniche, o particolari competenze: mi sono fatto guidare dalla musica, dalle liriche, dall’ispirazione; e dalle mie orecchie, dalla mente e dal cuore.
Questo pezzo è un piccolo omaggio a una band che mi ha saputo dare così tanto in questi trent’anni da fan: la mia passione enorme per gli Iron Maiden in qualche modo, prima o poi, doveva sfociare in un mare di parole. Alla fine ecco l’importante: parlare di questa leggenda del metal, perché altri imparino ad amarne i capolavori.
17) VIRTUAL XI – 1998
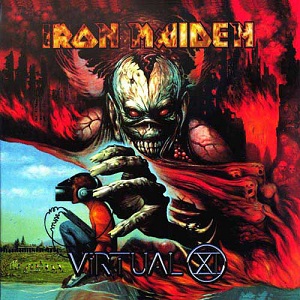
Dell’album che secondo me è il meno riuscito degli Iron Maiden, si possono trovare alcuni aspetti positivi: come ad esempio la canzone d’apertura, Futureal, che riprende le aggressive sonorità degli esordi.
Il brano più bello è The Clansman, un inno alla libertà e all’autodeterminazione:
“No, we can’t let them take any more / We have the land of the free – No, non possiamo lasciarli prendere altro / Noi abbiamo la terra dei liberi.”
L’urlo di Blaze Bayley, e l’epica composizione musicale, ti catapultano nella Scozia medioevale, in cima a uno sperone di roccia, in mezzo alle rivolte delle Highlands.
Va citata anche Como Estais Amigos, un melancolico motivo sul ricordo dei caduti in guerra per difendere la libertà delle future generazioni: assoli bellissimi e un testo di grande sensibilità:
“Como està amigo / For the death of those we don’t know / Shall we knee and say a prayer / They will never know we care – Come stai amico / Per la morte di coloro che non conosciamo / Dovremo inginocchiarci e dire una preghiera / Loro non sapranno mai che ci stanno a cuore.”
Le restanti canzoni non sono così entusiasmanti; a questo si aggiunga la voce di Blaze, che non fa decollare alcuni dei pezzi più veloci. Virtual XI, in definitiva, non è omogeneo: non viene voglia di ascoltarlo per intero. Si nota però come gli Iron Maiden sperimentino alcune sonorità che preannunciano la direzione musicale negli anni 2000; che verranno esaltate con la voce di Dickinson e la vena compositiva di Adrian Smith.
16) FEAR OF THE DARK – 1992

La disomogeneità è il principale motivo per cui Fear of the Dark si trova così in basso nella classifica; al suo interno ci sono canzoni troppo diverse tra loro: da Be Quick or Be Dead, supersonica apertura sull’ingordigia della finanza, a Wasting Love, unico vero lento nella discografia degli Iron Maiden; a From Here to Eternity, coinvolgente brano che chiude la saga della prostituta Charlotte mettendola in sella alla moto del diavolo; a Weekend Warrior, che parla degli hooligans e della stupidità della violenza fuori e dentro gli stadi; un pezzo poco maideniano, ma apprezzabile, per gli assoli velocissimi e passaggi di chitarra melodici. Sono presenti altre canzoni con temi sociali: Fear is the Key, rabbiosa denuncia sull’epidemia di AIDS taciuta dai media; e Childhood’s End – che riprende un titolo dei Pink Floyd: dove si parla dell’innocenza perduta di troppi bambini nel mondo.
Ci sono poi i due capolavori dell’album; il primo è Afraid to Shoot Strangers – Paura di Sparare agli Sconosciuti, sui tormenti di chi si trova in guerra per una giusta causa:
“Trying to justify ourselves the reasons to go / Should we live and let live? Forget or forgive? / But how can we let them go this way / The Reign of corruption and terror must end – Tentando di giustificare a noi stessi le ragioni per andare / Dovremmo vivere e lasciar vivere? Dimenticare e perdonare? / Ma come possiamo lasciarli continuare su questa strada? / Il Regno di corruzione e terrore deve finire.”
E’ una canzone costruita su una parte introspettiva e melodica, seguita da una selvaggia esplosione musicale: il combattente fa la sua scelta, e noi assistiamo allo sconvolgimento interiore delle sue azioni.
Il secondo capolavoro è Fear of the Dark, titolo e verso iconico per la sua ricorrenza nel testo: ascoltiamo le confessioni di un individuo in preda alla fobia di trovarsi da solo con le proprie psicosi. Un pezzo che ha reso celebri gli Iron Maiden a una vasta platea, e cavallo di battaglia dal vivo.
Le altre canzoni, per quanto divertenti, spezzano definitivamente il ritmo di un album già fin troppo variegato; ma che ogni tanto lo si ascolta saltellando da una traccia all’altra.
15) DANCE OF DEATH – 2003

Musicalmente, Dance of Death è un album riuscito, sebbene un po’ dispersivo nei testi e nei generi. E’ come un viaggio sull’ottovolante, con le paraboliche sonore di Wildest Dreams, The New Frontier, The Rainmaker. O ti imbarchi sugli sciabordanti ritmi di The Gates of Tomorrow, The Age of Innocence e No More Lies; o vieni shakerato dai rombanti riff di Montsegur, che parla dell’eccidio degli Albigesi nel XIII secolo; o resti come imbambolato lungo il crescendo assillante di Face in the Sand, pezzo sulla trasformazione dei cittadini in semplici spettatori.
La title track, invece, è una canzone semplicemente epica, piena di riff celtici lungo i suoi mirabolanti 8’36”: dove si racconta la casuale partecipazione di un uomo al gran ballo della morte, e la sua miracolosa fuga.
Di morte si parla anche in uno dei capolavori assoluti degli Iron Maiden: la sinfonica Paschendale, ispirata a una delle battaglie più orribili nella storia dell’umanità. Combattuta nel 1917 nelle Fiandre, nelle trincee di Passchendaele trovarono la morte centinaia di migliaia di uomini: la canzone ci offre il punto di vista di uno dei soldati, ormai prossimo alla fatale carica sotto i colpi delle mitragliatrici: un giovane senza nome, nazionalità, né età, senza orizzonti di gloria ma con il sogno, in quell’ultimo scampolo di vita, di una pace casalinga.
“Many soldiers eighteen years / Drown in mud / No more tears / Surely a war no-one can win / Killing time about to begin / Home far away / From the war / a chance to live again / Home far away / But the war, no chance to live again – Molti soldati diciottenni / affogati nel fango / Hanno finito di piangere / Sicuramente una guerra che nessuno può vincere / Il tempo delle uccisioni sta per ricominciare / Casa lontano / dalla guerra, un’opportunità di vivere ancora / Casa lontana / Ma la guerra, nessuna possibilità di vivere ancora.”
Un altro brano indimenticabile è il pezzo di chiusura, Journeyman, l’unica canzone acustica degli Iron Maiden: un delicato viaggio in una terra invernale, e nei dolenti pensieri di un uomo orgoglioso della sua indipendenza e della sua libertà; con versi di rara poesia:
“In your life you may choose desolation / And the shadows you build with your own hands / If you turn to the light / That is burning in the night / Then your journeymans’s day has begun – Nella vita può scegliere la desolazione / E le ombre che ti sei costruito con le tue mani / Se ti volti verso la luce / Che sta bruciando nella notte / Allora il tuo giorno da viaggiatore è cominciato.”
Perché allora Dance of Death è solo al 14° posto? E non più in alto? Potrei dire che i testi di almeno metà delle canzoni non sono memorabili; e che così tanti generi diversi spezzano un po’ il rito dell’ascolto. In realtà il motivo è che gli Iron Maiden hanno scritto tanti album belli; e qualcuno, nel gioco della classifica, deve per forza stare così indietro; oggi è toccato a Dance of Death, album che però, come si sarà capito, ascolto sempre volentieri.
14) THE X FACTOR – 1995

Alla fine ho ascoltato senza preconcetti anche The X Factor, cercando di giudicarlo in modo imparziale, come se non fosse nemmeno un album degli Iron Maiden; il risultato è stato sorprendente: mi sono trovato un disco unico per atmosfere ed energia. Si parla di album cupo, forse anche deprimente – Harris, autore o coautore di tutti i brani, viveva un periodo difficile non solo sul piano professionale, ma anche per la morte del padre e il divorzio dalla moglie. Ecco quindi che The X Factor non è un album deprimente, ma è una coraggiosa opera che affronta la depressione in tutte le sue declinazioni: dalla marginalizzazione all’isolamento, alla perdita di qualcosa o qualcuno, ai pensieri lesionisti o autolesionisti, allo stress post traumatico, alla psicosi. Con squarci di luce musicale che illuminano l’ascolto. Si parte con l’epica Sign of The Cross, che apre con un coro monacale e questi versi:
“Da solo in piedi, sotto la pioggia e il vento / sentendo la paura che sale / percependo un nuovo cambio della marea / preso nella tempesta che monta.”
E si finisce con The Unbeliever, un brano con riff entusiasmanti, e un ritornello che dice: “tutta la vita sono fuggito / ho cercato di nascondermi / ho lasciato che la mia fede si perdesse via“; per chiudersi con un’assoluzione finale per il dolore inflitto e sofferto:
Prova a lasciar andare la rabbia che hai dentro / Perdona i peccati immortali / Ti importa davvero quello che pensa la gente? / Sei forte abbastanza per scaricare il senso di colpa?
Se non si inquadra The X Factor con questa chiave interpretativa, ci si può impantanare nelle solite discussioni: la voce di Blaze; alcuni brani troppo lenti; un suono acustico a volte dominante; testi lontani dai temi maideniani. La verità è un’altra: questo album offre tanto a chi è capace di ascoltarlo, a chi si ritrova nelle liriche e nelle sensazioni veicolate dalla musica: infatti gli estimatori di The X Factor lo definiscono bellissimo. E la voce di Blaze, morbida e riflessiva, ma aggressiva al momento giusto, è un valore aggiunto. E’ perfino superfluo parlare delle altre nove canzoni, che pure regalano sonorità emozionanti e ritmi incalzanti: The X Factor è da ascoltare dall’inizio alla fine, con la voglia di imbarcarsi in un viaggio che porta nel “cuore di tenebra” che a volte discende nelle nostre vite; e da cui se ne esce, anche grazie alla musica.
13) BRAVE NEW WORLD – 2000

Si monti di nuovo l’idolo atteso da milioni di fan in tutto il mondo: dopo oltre un decennio, gli Iron Maiden dell’epoca d’oro ritornano per la felicità della comunità metallara. Brave New World, che segna il rientro di Dickinson e Smith, non poteva che aprirsi con la simbologia di The Wicker Man – l’Uomo di Vimini: una canzone ispirata al film omonimo del 1973, dove si raccontano gli orrori di una setta pagana che brucia idoli e vergini per la prosperità stagionale.
Dunque sono di nuovo tutti assieme i creatori dei mostri sacri; e l’album suona davvero come il ritrovo di vecchi amici che riannodano relazioni sospese da anni; come se il tempo non fosse mai passato per loro. Tuttavia, i cambiamenti non sono pochi. Sono sempre gli amati Iron Maiden, su questo non c’è dubbio; a partire da tracce bellissime come Ghost of the Navigator, Brave New World, The Mercenary: si sente l’inconfondibile ordito sonoro e culturale che li ha resi famosi negli anni ’80. Se ai primi ascolti, aspettandosi lo tsunami di energia alla Piece of Mind o Powerslave, si può rimanere delusi, col tempo si impara ad apprezzare questa nuova dimensione musicale: più elaborata, ma non per forza più lenta. Varie canzoni, in media, sono molto più lunghe rispetto all’epoca d’oro, proprio per esprimere meglio questa nuova cifra stilistica.
Ecco ad esempio un altro trio di canzoni splendide, Dream of Mirrors, The Nomad e The Thin Line between Love and Hate; prese singolarmente sono dei veri e propri viaggi: con vari cambi di ritmo e più d’un ritornello; con riff e assoli ramificati su molteplici scale e velocità. Una direzione impressa, con sorprendenti declinazioni, in tutti gli album del nuovo millennio; del resto la canzone Blood Brothers – Fratelli di Sangue – rappresenta il patto dietro al nuovo progetto artistico. “The dream is true“, canta Dickinson in Dream of Mirrors: il sogno è reale; ma è quello dei fan o dei sei musicisti che ultraquarantenni si rimettono in gioco? Senza timori reverenziali verso i se stessi del passato?
Con Brave New World la “sottile linea tra odio e amore” – dal titolo del pezzo di chiusura dell’album – è stata tracciata: sta a noi scegliere da che parte stare. E la mia scelta, sebbene maturata dopo tanti anni, è quella di amare ognuna di queste tracce, e i successivi lavori.
12) IRON MAIDEN – 1980

L’album d’esordio più folgorante nella storia metallara: Iron Maiden ti acchiappa sin dal primo riff di chitarra, nella grezzissima The Prowler; e ti incanta con il melodico inizio di Remember Tomorrow, per poi stordirti con la caleidoscopica seconda parte della canzone. Non fai in tempo a riprenderti, che vieni letteralmente preso a mazzate con l’intro di batteria di Running Free, inno degli scapestrati per eccellenza: notti in macchina, alcol, sesso, discoteca, risse: il correre sfrenato e libero per tutti i tuoi sedici anni. Impossibile, da giovane, non amare questa canzone. Nei dodici minuti d’apertura dell’album, si è investiti di tutta l’energia dei primi Iron Maiden, con la voce ora limpida ora punkeggiante di Paul Di Anno, la mesmerizzante ritmica della batteria di Clive Burr, più l’incredibile basso di Harris, e le travolgenti chitarre di Murray e Dennis Stratton, con riff graffianti e assoli micidiali.
La quarta traccia è il capolavoro dell’album, e un classico degli Iron Maiden: Phantom of the Opera, i sette minuti che hanno trasformato il punk-rock e la new wave britannica nel metal degli anni ’80. A cui si sommano i 4’20” di Transylvania, una canzone strumentale dove chitarre, basso e batteria sembrano rincorrersi in un labirinto musicale; come se Harris, il fondatore degli Iron Maiden, volesse chiarire a tutti che razza di sound proponeva la sua band.
Solo dopo un tale manifesto musicale i Maiden si permettono Strange World, un sognante e lisergico brano; per poi ributtarci nel vortice di Charlotte the Harlot, e finirci tutti con Iron Maiden, title track e nome della band. Un rimando alla Vergine di Ferro, tortura medioevale tramite un sarcofago pieno di spuntoni. Una canzone intramontabile proposta immancabilmente in ogni tour per il delirio dei fan.
Ma se Iron Maiden è così spettacolare, perché è fuori dalla mia top-10? Perchè nell’età della maturità un testo come quello di Running Free mi fa guardare con tenerezza all’età dei 16 anni; e storie di sangue, incubi e violenze, contestualizzate in modo diverso, possono elevare canzoni musicalmente meno folgoranti, ma in generale più significative.
11) THE BOOK OF SOULS – 2015

L’ultimo album degli Iron Maiden in ordine cronologico è forse quello che esprime l’anima profonda di questa quarantennale band: cavalcare la musica più selvaggia, imbrigliandola a una potente poetica descrittiva e metaforica; immagini proiettate nella mente di chi ascolta grazie alle capacità canore di Bruce Dickinson.
Non si può restare non ammirati da The Book of Souls, se si pensa che è arrivato 35 anni dopo l’esordio di Iron Maiden. Si prenda If Eternity Should Fail, l’opener dell’album: la stessa carica è lì, nell’epico riff, combinato alla tormentata linea vocale; e la stessa energia è nelle mazzate di tamburo sul finale del pezzo, dopo una serie di travolgenti assoli. “Here is the soul of a man – ecco qui l’anima di un uomo“, canta Dickinson; ma è l’anima dei sacri Iron Maiden che viene evocata, con il primordiale intro che ci riporta a una Terra all’alba della vita. Come si fa a non amare questo e altri pezzi?
Come ad esempio The Great Unknown, con un incedere canoro e sonoro che monta come una tempesta di vento; sembra di osservarla la scena, i riff di chitarra come folate sulle praterie dei nativi americani, terrorizzati dall’arrivo dei colonizzatori; i quali si avvicinano sempre di più alla popolazione e non lasceranno scampo a nessuno.
Never ending the desires of men / It will never be the same or calm again / In a time of changing hearts and great unknown / It’ll be the damnation and the end of us all – Non hanno mai fine i desideri degli uomini / Non sarà mai più lo stesso, e mai più la calma / In un tempo di cuori che mutano e il grande ignoto / Sarà la nostra dannazione e la fine per tutti noi.”
Il passo maideniano di queste due canzoni si sviluppa lungo tutto l’album; con un phatos quasi sciamanico in The Red and the Black e nella title track: in queste tracce, entrambe oltre i 10 minuti, la vena compositiva degli Iron si sbizzarrisce; musica, linee vocali, cori: tutto si incastra alla perfezione, e l’ascoltatore “vive” l’album.
Merito di una produzione davvero grandiosa. Forse, insieme a The Final Frontier, questo è il miglior lavoro di Kevin Shirley, che dal 2000 in avanti ha seguito la registrazione degli album degli Iron Maiden in ogni fase.
Tutte le altre tracce offrono spunti notevoli, pur con margini di tempo più ristretti: e ne fanno un album omogeneo e godibile per intero, pur estendendosi per 70 minuti abbondanti.
In realtà The Book of Souls dura 92’11”; ma l’ultima canzone, Empire of Clouds, merita un capitolo a parte. Composta da Bruce Dickinson, è un’opera di 18 minuti che potrebbe essere tranquillamente esibita in un teatro, con l’orchestra nella fossa e un corpo di ballo sul palco. Empire of Clouds è la storia del disastro del R101, il dirigibile che nel 1930 si schiantò su una collina in Francia, causando la morte di 48 persone tra equipaggio e passeggeri; ed è la metafora della sfida umana alle leggi della fisica, per conquiste sempre più ardite. E’ semplicemente un capolavoro dall’inizio alla fine; passando per il riff di chitarra che mima l’SOS lanciato dal dirigibile, prima di inabissarsi verso il suo destino.
10) NO PRAYER FOR THE DYING – 1990
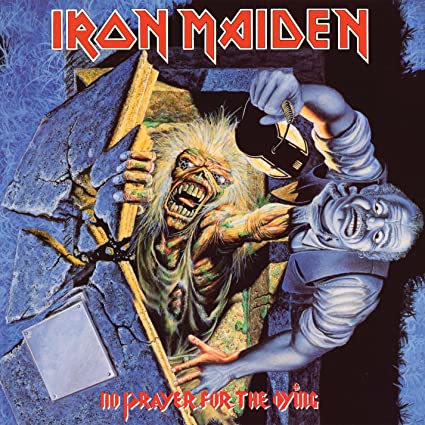
La Sonata per Pianoforte n. 14 di Beethoven è paragonabile alla Sinfonia n. 5? O alla Sinfonia n. 9? No, perché sono due composizioni diverse; non per questo però la Sonata per pianoforte n. 14 è da buttare, solo perché non ha il respiro e l’articolazione di una sinfonia: una volta chiarito questo punto, la si celebra come uno dei capolavori di Beethoven.
Con le dovute proporzioni, lo stesso metro di giudizio va applicato a No Prayer for the Dying, album del 1990 che segue due delle maggiori “sinfonie” degli Iron Maiden. Il fatto che non fosse all’altezza di opere epiche e concettuali come Somewhere in Time o Seventh Son of a Seventh Son, all’epoca lasciò perplesse le orde di fan maideniani. Tuttavia, No Prayer for the Dying ha retto benissimo il passare del tempo: ancora oggi è un album divertente e godibile dall’inizio alla fine; con qualche passaggio a vuoto, come ad esempio l’itterico coro di Bring your Daughter to the Slaughter; o Hooks in You, canzone che bordeggia l’hard rock in un album squisitamente metal.
Paradossalmente Bring your Daughter è stato l’unico singolo salito al 1° posto delle classifiche di vendita in Gran Bretagna; mentre Hooks in You è un brano co-firmato da Adrian Smith, che abbandonò la band in fase di pre-produzione perché non condivideva la nuova linea artistica di Harris. Ovvero brani più corti, diretti e senza fronzoli, riacquistando l’immediatezza dei primi album. Il costo è stato disperdere tutta l’epica maideniana costruita negli otto anni precedenti, e spingere Bruce Dickinson a cantare con un timbro vocale spesso molto roco. Purtroppo l’uscita di Smith ha ridimensionato la capacità di scrittura musicale: Harris ha confezionato un disco apparentemente mediocre se paragonato ai mostri sacri; prodotto per altro nello studio di registrazione che si era costruito nel giardino di casa.
Il risultato è un (in)successo.
Si potrà sempre criticare No Prayer for the Dying, o far finta che non esista; ma chi ne accetta i limiti, ha imparato ad ascoltarlo e apprezzarlo per i suoi numerosi meriti. Il primo fra tutti, la tensione che corre rapida e ininterrotta per tutto l’album; a partire dalla gragnola di ride e riff che aprono Tailgunner, l’opener dell’album: un pezzo che, spinto da una serie di assoli di chitarra, un giro di basso iconico, e acuti vocali, sembra scalare il cielo e portarci sopra Hiroshima: il tail gunner, l’artigliere sul retro del caccia-bombardiere, è testimone dello sganciamento della bomba atomica; con uno “yahoo” di Dickinson che fa il verso a Il Dottor Stranamore di Kubrick, quando il capitano Kong urla per essere riuscito a sbloccare l’ordigno, e lo vediamo precipitare in groppa a Hi There.
E dopo l’elettrizzante e funambolica Holy Smoke, si arriva all’unico brano lento dell’album: la title track; o meglio, una parte di essa; perchè No Prayer for the Dying, se nella prima metà esprime la malinconia di un individuo pieno di dubbi esistenziali, nella seconda esplode in un tumulto strumentale e vocale, a raffigurare un disperato bisogno di risposte: “God give me the answer to my being – Dio dammi la risposta al mio esistere“.
Un gioiello, la title track, che apre la strada al tesoretto dell’album: il filotto di brani che va da Public Enema Number One a Fates Warning, a The Assassin e Running Silent Running Deep: emozioni che guizzano su melodie accattivanti e assoli esaltanti, con Dickinson che quasi si amalgama alla musica, piuttosto che stagliarsene al di sopra.
L’album si chiude con Mother Russia, omaggio alla libertà conquistata nei Paesi dell’Europa dell’est dopo il crollo del comunismo. Un brano evocativo di un paesaggio da steppa, con uno stile epico, vagamente somigliante a Seventh Son of a Seventh Son: ovvero il pezzo più epico nella discografia degli Iron Maiden; e forse per questo Mother Russia non ha mai trovato spazio nei cuori dei fan.
In definitiva, No Prayer for The Dying me lo ascolto per intero anche tre volte di fila senza stancarmene; come faccio a tenerlo fuori dalla top-10? La domanda è un’altra: perchè dopo trent’anni questo disco è ancora in disgrazia? E non è considerata l’8° meraviglia dell’epoca d’oro dei Maiden?
9) PIECE OF MIND – 1983

Nella mia prima stagione d’amore per gli Iron Maiden, l’ho ascoltato un milione di volte. Piece of Mind è musicalmente magistrale, a partire dall’attacco di batteria dell’opener, Where Eagles Dare: Nicko McBrain picchia, rulla e pesta impostando un ritmo forsennato, col basso di Harris a macinare in sottofondo un galoppo; a cui si adeguano le chitarre gemelle di Murray e Smith, con un riff pesante come una sassaiola; pavé da cui poi fiondano, in coppia o singolarmente, assoli deliranti che spaziano su tutto il manico dello strumento. E su questo paesaggio musicale, come un’aquila maestosa, vola altissima la voce di Bruce Dickinson.
E’ il filo conduttore, a livello sonoro, lungo l’album in quasi tutta la sua interezza: un leit-motiv ripreso con passo più civile e melodioso, ma altrettanto epico, in alcune canzoni; o lanciato come una palla di cannone in altre, come se l’intento degli Iron Maiden fosse fare breccia in qualcosa di impenetrabile. E in effetti con questo album si sono aperti orecchie e cuori di una platea mondiale, e di conseguenza di una quota enorme di mercato in Europa e negli Stati Uniti. Il successo di critica e di pubblico per Piece of Mind convinse i Maiden a impegnarsi, nel 1984, nel World Slavery Tour, con 189 date negli stadi di tutto il mondo; consacrandoli, in contemporanea all’uscita di Powerslave, come la più grande metal-band dell’epoca.
“You’ll take my life but I’ll take yours too / You’ll fire your muscket but I’ll run you through“
L’inizio di The Trooper, al pari dei grandi successi dei Black Sabbath e o dei Deep Purple, era mandato a memoria da ogni ragazzino del pianeta che si accostasse al rock e al metal.
La forza dell’album non si concentra solo nella musica, ma anche nei testi, quasi tutti ispirati a riferimenti culturali, sia di massa che ricercati. Harris e soci hanno preso spunto da materiale biblico-letterario, come in Revelations; classico, in Flight of Icarus; cinematografico, in Where Eagles Dare e Still Life; storico-letterario, in The Trooper e Sun and Steel; antropologico, come Quest For Fire; letterario, in To Tame a Land. Queste diverse forme d’arte diventeranno la bussola stellare a cui gli Iron Maiden si rivolgeranno spesso per scrivere le loro liriche; un esercizio che ha contribuito a generare l’ipertesto etico e filosofico palpabile in tutta la discografia della band inglese.
Proprio con To Tame a Land, basata sul romanzo fantascientifico Dune, gli Iron Maiden consolidano la vocazione intravista in alcune tracce di The Number of the Beast: uno stile narrativo di respiro più ampio, con brani lunghi, complessi, con le emozioni veicolate dalla musica; ma incordati in un vero e proprio racconto, piuttosto che appiccicandoci sopra frasi estemporanee, come se fossero tavole da fumetto. E’ un esperimento riproposto con convinzione in successivi lavori degli anni ’80 – in Somewhere in Time con un piano concettuale sull’intero album; e ripreso come direzione artistica da Brave New World in poi.
La semplicità di alcuni testi, con ritornelli schematici in canzoni di per sé già “brevi”, rappresenta il vero motivo per cui un capolavoro come Piece of Mind è solo all’ottavo posto nella mia classifica. Se è vero che il racconto del mito in Flight of Icarus è straordinario, e la poetica in Revelations è molto evocativa, le liriche di Piece of Mind sono solo un assaggio del potenziale autoriale di Harris, Dickinson e Smith: uno stile maideniano che maturerà definitivamente negli album successivi.
8) SEVENTH SON OF A SEVENTH SON -1988

Il rippling effect di questo album, l’increspatura sonora che si è propagata dall’istante in cui uscì, non avrà mai fine; la potenza musicale di Seventh Son of a Seventh Son è paragonabile, mi ripeto, a un maremoto apocalittico: e si genera ogni volta che si suona questo disco. Come se i fondali marini tremassero alle sbracciate di Nicko McBrain sulla batteria; e mulinassero le acque coi giri di basso di Harris, e soffiassero come venti impetuosi i sintetizzatori; e si rannuvolassero i cieli con i riff delle chitarre di Murray e Smith, e gli assoli li squarciassero come saette. E su tutto questo, cataclismatica, la voce di Bruce Dickinson: il quale, con performance da attore drammatico, trasmette il phatos di un’opera in stile fantastico sul bene e sul male. Perchè questo è Seventh Son of a Seventh Son: narra per immagini misticheggianti di lugubri presagi e figli prescelti, di lotte fra angeli e demoni, di poteri divinatori e premonizioni inascoltate, della paura di morire dannati, e di sciagure che si avverano, dell’innocenza di una nascita, e la tentazione del maligno. Sono vari gli orrori che scorrono senza tregua nei testi, in un martellante messaggio che è riassumibile in alcuni dei versi delle otto canzoni:
Nell’epica Moonchild – Figlio della Luna:
“And if you try to save your soul, I will torment you – e se proverai a salvare la tua anima, ti tormenterò.”
Nella selvaggia Infinite Dreams – Sogni Infiniti:
“Help me / Help me to find my true self without seeing the future / Save me / Save me from torturing myself even within my dreams – Aiutami / Aiutami a trovare il vero me stesso senza indagare nel futuro / Salvami / Salvami dalle torture che m’infliggo persino nei sogni.”
Nella giostrante Can I Play with Madness – Posso Giocare con la Pazzia?:
“Give me the sense to wonder / To wonder if I am free – Dammi la percezione di chiedermi / Di chiedermi se io sia libero”
Nella travolgente The Evil That Man Do – Il Male che l’Uomo Compie:
“The evil that men do will live on and on – il male che l’uomo compie continua a vivere”;
Nella monumentale title track, Il Settimo Figlio del Settimo Figlio:
“Here await, the birth of the son / […] / Then They watch the progress he makes / The good and evil / which path will he take? – Ecco che attendono la nascita del figlio / […] / Poi ne osservano i progressi / Il Bene e il Male? / Quale via prenderà?”
Nella teatrica The Prophecy – La Profezia:
“It’s so hard to understand / that I am the real seventh son / Your life or death on me depends / Impending disaster / (Souls crying) the devil’s laughter – E’ così difficile capire che sono il vero settimo figlio? / La vostra vita o morte dipendono da me / Il disastro incombe / (Anime che piangono) la risata del diavolo.”
Nella fantastica The Clayrvoiant – L’indovino:
Just by looking through your eyes / He could see the future penetreting right / in through your mind / See the truth and see your lies / But for all his powers couldn’t see his own demise – Gli bastava vedere nei tuoi occhi / Poteva vedere il futuro penetrare giusto nella tua mente / vedere la verità e vedere le tue bugie / Ma per tutti suoi poteri, non riusciva a vedere la sua propria rovina”
E nell’ultima traccia, la torrenziale Only the Good Die Young – Solo i Buoni Muoiono Giovani:
“Only the good die youg / All the evil seems to live forever – Solo i buoni muoiono giovani, Tutto il male sembra destinato a vivere per sempre”.
Un album capolavoro. Oscuro e a tratti deprimente per le liriche; limpido e liberatorio per la musica.
Sono cosciente che posizionare Seventh Son of a Seventh Son così indietro nella classifica farà gridare allo scandalo; soprattutto per almeno un paio di album che gli stanno davanti. Tuttavia, leggendo con onestà i testi, lo vedo come velleitario nella sua volontà di grandezza; soprattutto se si pensa che gli Iron Maiden avevano già scritto veri e propri poemi, e opere nel loro insieme ben più riuscite a livello concettuale. Per questo, secondo la mia opinione, Seventh Son of a Seventh Son brilla di minor luce “artistica”, se paragonato ad altri lavori che cronologicamente lo precedono e che lo seguono.
7) THE FINAL FRONTIER – 2010

Alla fine ho capito perché The Final Frontier mi piace da matti: è un sincero atto d’amore degli Iron Maiden verso il rock; a cinquant’anni suonati, pubblicano un disco-tributo alla musica che li ha portati a diventare delle stelle. Ed è l’opener dell’album, una composizione sperimentale, a darci questa chiave interpretativa: Satellite 15… è un omaggio a Astro Domine, la prima traccia del primo album dei Pink Floyd. Il rock a cavallo tra gli anni ’60 e gli anni ’70 è stata la “via interstellare” per quel gruppo di ragazzi, capitanati da Steve Harris, di costruire la galassia Iron Maiden; in un viaggio che, a distanza di 45 anni dalla fondazione del gruppo, è ormai senza ritorno. Ed ecco …The Final Frontier – la seconda traccia – in cui l’astronauta naufragato nello spazio, senza più contatti con la Terra, fa i conti con la propria esistenza:
“Ho avuto una buona vita / Rifarei tutto da capo / Forse tornerò ancora / di nuovo in un qualche altro tempo / Perché ho vissuto la mia vita al massimo / E non ho rimpianti.”
Un tema, l’odissea spaziale per una Terra perduta, che ricorre in altre canzoni, e che eleva The Final Frontier ad album costruito su più piani concettuali.
Seguendo la lettura del tributo alla musica, il successivo omaggio è per i Metallica, il gruppo che negli anni ’80 ha reso popolare il metal ovunque, allargando la via agli Iron Maiden nel continente americano; il caos strumentale che parte con El Dorado ricalca l’apertura di Hit the Lights, prima traccia del primo album della band californiana. A livello lirico, la caccia all’oro di cui si parla nel testo è un riferimento alla Grande Crisi, scoppiata un paio d’anni prima dell’uscita di The Final Frontier; gli incalzanti riff di chitarra arricchiscono un pezzo dove Dickinson può esprimere tutta la sua teatralità. E non può sfuggire all’orecchio un accenno dell’iconico riff di chitarra su giro di basso di I Was Made for Lovin’ You, dei Kiss, rock-band di culto già negli anni ’70.
Un altro omaggio si trova in Mother of Mercy, canzone su un eccidio “su scala non comprensibile”; è riconoscibile anche perché viene citato nel testo: è In My Darkest Hour, un pezzo dei Megadeth – megadeath significa appunto, morte su ordini numerici enormi. La band di Dave Mustaine è un altro faro del metal americano; “waiting for my darkest hour“, canta Dickinson, poco prima di uno stupendo assolo che, seppur rivisitato, echeggia quello scritto da Mustaine.
Poi c’è la ballatona Coming Home e le sue splendide immagini che raccontano di un amaro ritorno nell’orbita terrestre; l’astronauta rivede la Madre Terra, ormai rovinata dopo le guerre e le catastrofi accennate in Mother of Mercy e When the Wind Blows; e da cui la civiltà umana è dovuta partire per la sopravvivenza. Nella canzone si riconoscono gli arpeggi svolazzanti di Little Wing, immortale successo di Jimi Hendriks.
E come non collegare la pizzicata di chitarra di The Battle of Evermore dei Led Zeppelin all’inizio di Isle of Avalon, o gli elettrici sfondi di chitarra di Eddie Van Halen negli assoli centrali; incastonati in una canzone che assomiglia a una preghiera cerimoniale per la rinascita della Madre Terra.
In Starblind invece c’è un’autocitazione, ovvero la ripresa di linee sonore di Seventh Son Son of a Seventh Son, il disco che aumentò il loro status di leggende del metal. Una canzone, Starblind, di bellezza abbacinante, con gli assoli di chitarra che ci accompagnano nel viaggio interstellare di uno spirito che sulla Terra era rimasto intrappolato nei dogmi religiosi; e che solo dopo la morte riconosce nel sole l’energia creativa sulla Terra.
Sono gli assoli di Lou Reed, nell’intro di Sweet Jane live 1972, e di Derek and the Dominos, in Layla, che gli Iron Maiden omaggiano nella parte centrale di The Man Who Would Be King; un pezzo di introspezione, con un uomo che viaggia con “the burden of beast, il carico della bestia“: che è il peso di una colpa terribile; ma che può essere interpretato anche come il peso dei vecchi successi, ad esempio The Number of the Beast.
Le filamentose chitarre dei Deep Purple si distinguono nella parte centrale di The Talisman, una delle più belle tracce in un disco spettacolare, ma senza capolavori universalmente riconosciuti come tali. Ancora una volta si narra una storia di mare, con la traversata oceanica di un gruppo in fuga da morte e persecuzioni. Un testo che si applica al passato – le migrazioni dall’Europa al Nuovo Mondo; al presente – i viaggi della speranza nel Mediterraneo; e a quel futuro nello spazio profondo, via da una Terra inabitabile, di cui si parla nell’album.
Un disco che infatti si chiude con When the Wind Blows, canzone che mette in musica l’omonimo film animato del 1986, diretto da Jimmy Murakami e scritto dall’illustratore Raymond Briggs. E’ la storia di una coppia di sopravvissuti all’olocausto nucleare; la colonna del film in realtà era stata scritta da Roger Waters: e in suo omaggio, gli Iron Maiden scelgono di aprire e chiudere la canzone con il soffio del vento; che però, nell’interpretazione di Harris e soci, assomiglia a quello di One of These Days, capolavoro di Waters nei Pink Floyd: il gruppo celebrato nella prima traccia di The Final Frontier.
Questo album merita una posizione alta o bassa in classifica? A furia di ascoltarlo, per rispondere a questa domanda, The Final Frontier la mia classifica personale l’ha scalata fino a qui; e si è fermato solo davanti a vette musicali e liriche che considero l’Himalaya degli Iron Maiden.
6) KILLERS – 1981

Una deflagrazione di fuochi d’artificio dalla prima all’ultima nota, con una vibrazione acustica che mi attraversa ogni santa volta che suono il disco: posso ascoltare Killers tutto il giorno, e per tutto il giorno Killers mi regala la stessa meraviglia della prima volta. Diventa trascurabile che sia un disco sotto i 40 minuti, con due pezzi strumentali; e che si presenti come una parodia di album concettuale sul tema dell’assassinio: in quasi tutte le tracce si parla di omicidi, sequestri, fantasmi e follia, ma col tono da fumetto; sintetizzato dall’iconica copertina di Dereck Riggs, primo illustratore dei Maiden e inventore della mascotte Eddie. Un concetto perfino indotto per associazione di idee: le due canzoni strumentali, Ides of March e Genghis Khan, sono intitolate all’assassinio di Giulio Cesare, e al sanguinario condottiero mongolo.
E Killers è il primo album prodotto da Martin Birch, che aveva già lavorato con Rainbow, Whitesnake e Black Sabbath. Ecco, Birch prese in mano il timone della nave di Steve Harris, e guidò gli Iron dalle correnti punk-rock della New Wave degli esordi alle epiche cavalcate metal di Seventh Son; fino al gorgo di No Prayer for the Dying, dove la nave cominciò a girare su se stessa, e con Harris solo al comando rischiò di affondare verso la fine degli anni ’90.
In quel 1981, però, nel gorgo maideniano ci finiva chi ascoltava per la prima volta Killers: il batterista Clive Burr ingaggia un ritmo che fa volare tutta la band, con rullate stordenti e i piatti sempre tonanti; il basso di Harris è una ininterrotta scossa tellurica; le chitarre gemelle di Murray e Smith, riunite per la prima volta, s’intrecciano con riff e assoli arcuati come le traiettorie di razzetti impazziti; la voce arrogante e vendicativa, ma con acuti da brividi, è di un grandissimo Paul Di Anno. I cambi di ritmo sono innumerevoli, con esplosioni imprevedibili, o passaggi di improvvisa calma melodica, prima di nuovi assalti elettrizzanti.
Il mio stupore, e la mia incredula gioia nell’ascoltarlo, saranno sempre più forti di qualsiasi critica, pur meritata, verso questo album: per me Killers è sempre lì in agguato, pronto a farsi suonare in ogni momento; e non mi stancherà mai.
5) SENJUTSU – 2021
Una cattedrale musicale: ecco cosa è Senjutsu, doppio album realizzato da una band i cui membri sono sulla soglia dei 70 anni; come se volessero lasciare indietro, per i fan di ogni età e generazione, un luogo sacro dove si celebrano i classici riti maideniani: con sonorità rivisitate dagli album del passato remoto o prossimo, ma con uno spirito di reinvenzione che addobba l’opera una sorprendente originalità.
In Senjutsu si entra direttamente dalla title track, battezzati dal potente tamburo di Nicko McBrain, e scortati dai flagellanti riff di chitarra della trinità Smith-Murray-Gers. In cima a un ideale pulpito Bruce Dickinson invoca l’adunata, e carica i fan per un album da ottanta minuti: articolato, complesso, di lotta quasi fisica perché si ascenda spiritualmente alla sua comprensione. Il paradiso però è un premio quasi immediato, con una linea vocale che eleva l’ascoltatore a una dimensione sonora di bellezza stordente; ed è così per tutto l’album, con Dickinson che vola più radente rispetto agli album vecchi o più recenti, ma con una prestazione ammirevole. All’interno di questa cattedrale, si è avvolti dalle melodie delle chitarre, che galleggiano come sipari di ondulanti luci, e s’accendono in elettrizzanti assoli. Il tutto, sulle solide fondamenta della ritmica del duo McBrain-Harris.
Ed è grazie alla scelta artistica di Harris – autore o co-autore dei brani più lunghi – che si entra in questa cattedrale senza per forza rimanervi per 80 minuti: si può varcarne la soglia anche solo per una pausa di contemplazione lungo i 12’39” di The Parchment; l’epica di un regno perduto e riconquistato, con il suo intro desertico, i riff morbidi come dune, a gli assoli che disegnano profili di vette e volte stellari; o per l’allucinato viaggio in The Time Machine, il resoconto in 7’09” di un uomo che racconta storie in tono ammaliante, “ma non è un predicatore: solo, ha visto cose che noi non possiamo nemmeno immaginare”. Un tempio, Senjutsu, dove si può persino passare di fretta, per trovare l’energia giusta nelle note delle mulinanti Stratego e Days of Future Past, entrambe sotto i 5 minuti.
Tuttavia è proprio dal colpo di tamburo che apre l’album, e dalla prima stanza della title track, che si è introdotti al tema principale dell’intera opera:
“Batti l’allarme, il suono dei tamburi / Accendi i segnali luminosi per tutti loro / La chiamata alle armi di tutti gli uomini di ogni dove / Devono combattere per la dinastia, è in gioco l’orgoglio / Respingere i ribelli dal nord / Tenere fuori i nomadi che giungono dalle pianure / Le praterie settentrionali sono inondate di tutti loro / Bloccare le tribù che stanno a sud. / Radunarsi attorno all’appello / Sentiamo da lontano i distanti suoni dei tamburi / E hanno bisogno di tutti alla muraglia / Ecco che cade il giorno del giudizio su di noi”
E’ “l’assedio” il tema di Senjutsu, parola che in giapponese significa “tattica e strategia”, ma intesa anche come spirito ed equilibrio per affrontare le sfide esistenziali. Un concetto, quello dell’assedio, che attraversa tutto l’album: in luoghi ideali, dalla “fortezza” della title track, al regno ancestrale The Parchment“, fino alla “nazione in lacrime” da difendere in Stratego. Tanto ideali, in fondo, non sono: perché l’assedio è vissuto dal guerriero antenato, in Death of a Celt; il quale prima della battaglia prega che “la rosa – il simbolo della monarchia britannica – sia ancora sveglia, viva”. Ed è l’Albione di Winston Churchill, “solo e nudo accanto ai troni dei re”, che in Darkest Hour – L’ora più buia – “ha appena seppellito i figli” della patria periti nella disastrosa ritirata di Dunkerque, durante la II Guerra Mondiale: ma “per sei lunghi anni i barbari resteranno alle porte / noi vinceremo”. Una canzone, Darkest Hour, con un intro vibrante di straziante commozione, e un corpo d’assoli semplicemente glorioso.
Gli Iron Maiden in Senjutsu sembrano inneggiare a un nazionalismo più nostalgico che politico: la difesa di questa “terra sacra”, con la critica a chi “danza sulle tombe di chi ha versato il sangue per noi” – immagini ricorrenti nell’album; insieme a un sentimento di sgomento per il presente, esaltato nella stanze finali di Lost in a Lost World – Spersi In Un Mondo Disperso – recitate da Dickinson, più che cantate:
“Riusciremo mai a guarire le nostre vecchie ferite, come una sempiterna logora oscurità / Combattendo di nuovo per le loro vite, e allora forza, non avere paura / E’ lì che giace il nostro destino, solo per farci respirare ancora / Messi su questa terra per vagare e camminare per sempre spersi / Con le ceneri dei nostri nemici a vivere fra i nostri fantasmi / Del nostro passato non temere nulla, la vita è solo un cammino sempre migliore verso la gioia / Nessun luogo dove andare, nessun luogo dove scappare, l’intera nostra nazione invasa / La sua stessa esistenza è minacciata e presto nessuno di noi sarà rimasto / Ricorda i nomi di tutti i nostri morti adesso nei nemici che fuggirono / Raggiungendo per sempre il cielo, libera una tristezza che è orgoglio / Mentre le nuvole ora si allontanano / Fino a quando ci incontreremo di nuovo.”
Senjutsu è stato scritto nel 2019, durante il periodo di stallo per gli accordi sull’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea; una scelta della maggioranza dei britannici, soprattutto degli inglesi, con il referendum del 2016. All’epoca Dickinson stesso si era sbilanciato in favore della Brexit, spiegando che un ritorno a una completa sovranità fosse la strada giusta per il Paese. Si può essere in disaccordo con questa visione, ma non ci si può sottrarre dal considerare questo lavoro come un’opera riuscita; e in fin dei conti come testimonianza di un passaggio cruciale della Gran Bretagna e se vogliamo di un’epoca. Nell’album si percepisce lo spirito di quella controversa scelta: compiuta da cittadini di una certa età pervasi dalla paura di fronte a una globalizzazione inarrestabile, e timorosi di veder erosi i valori e le certezze in cui sono cresciuti; magari compromettendo il sacrificio dei padri che avevano combattuto per la libertà e le conquiste sociali della Nazione.
La modernità del messaggio, tuttavia, è in questa fiducia, nonostante i dubbi, nel futuro; unita alla certezza che indietro non si può tornare: tutto cristallizzato nelle liriche della canzone di chiusura dell’album, la strepitosa Hell on Earth – Inferno in Terra:
“Tutto quello che sei stato, tutto quello che hai visto / Perso da qualche parte nei tuoi sogni. / Come è successo che gli angeli siano caduti / Niente di tutto quanto è quello che sembra / E le voci che ora senti / E le voci nella tua testa / Ora stanno pensando a una vita intera / Che non potrai mai più vivere.“
Con la presa d’atto che il mondo va avanti, e “pur volendo tornare indietro non si può rimanere sempre gli stessi”, non viene però risparmiata la finale ammonizione:
“La conoscenza e la virtù, sorprese dalla bramosia / Vivono ai margini delle persone di cui ti fidi / Tu pensi di avere le risposte per tutto quanto / Nel tuo modo di essere arrogante, hai un’unica via per cadere / Bruciando una lanterna che è fuoco nelle tue mani / che ti porta ancora più lontano da queste terre.
Amore nella rabbia, vita in pericolo / Perso nella rabbia, vita in pericolo.”
Le ultime liriche dell’album, nel ruvido cantare di Dickinson, suonano come uno schiaffo; una sveglia definitiva in risposta all’intro ebbro e ipnotico di Hell on Earth, stirato in oltre due minuti di balsamico dormiveglia. Una melodia ripresa per il finale della canzone e per la chiusura dell’album; ma che non ha una vera fine, visto che la musica sfuma, cullandoci in un indefinito orizzonte sonoro. Il nostro orecchio non riesce più ad ascoltarli, ma è perché la cerimonia è conclusa; gli Iron Maiden stanno continuando a suonare nella cattedrale che hanno eretto: siamo noi a uscire di scena, con emozioni vere sulla pelle, e vive nell’anima.
4) POWERSLAVE – 1984

Questo non è un semplice album musicale: è un portale dimensionale; le tracce di Powerslave, come i cunicoli delle piramidi proiettavano verso le costellazioni, ti aprono varchi spazio-temporali.
In una battaglia nei cieli della seconda guerra mondiale, come in Aces High, l’opener più celebre degli Iron Maiden. Ricordo una festa scolastica che non decollava, con la pista da ballo deserta: il disc-jockey suonò questo pezzo come se fosse l’ultima carta; all’intro delle chitarre gemelle, vidi ragazzi e ragazze involarsi sotto le luci stroboscopiche, e all’arrembante cambio di ritmo, con Dickinson che urla “There goes the siren that warns of the air raid…“, presero a danzare il mosh, cantando a occhi chiusi con i pugni al soffitto; o a quel cielo dove “corri per vivere / vivi per volare / voli per vivere / fai così o muori“. Liriche che nella mente dei giovani trascendono il testo, acquistando un valore che potremmo chiamare filosofia di vita.
Poi c’è la traccia che apre un passaggio nella camera mortuaria al centro della piramide: lì dove giace la mummia del faraone appena rinchiuso nel sarcofago. Nell’interpretazione divina di Dickinson, si dà voce allo spirito dell’uomo che sulla Terra era venerato come dio:
Tell me why I have to be a Powerslave / I don’t wanna die I’m a God why can’t I live on? / When the life-giver dies all around is wasted / And in my last hour I’m a slave to the power of death – Dimmi perché devo essere uno schiavo del potere / Non voglio morire, sono un Dio perché non posso continuare a vivere? / Quando colui che dona la vita muore, tutt’attorno è perduto / E nell’ultima mia ora sono uno schiavo del potere della morte.
Una stanza poetica sulla sete di vita contrapposta alla nostra mortalità, compresa quella di un faraone; ed è la riflessione che si può fare su uno qualsiasi dei tiranni della storia umana, e della memoria maledetta che tutti loro si lasciano alle spalle. Un capolavoro assoluto sotto tutti i crismi musicali; con un intermezzo strumentale di quasi tre minuti fra i più evocativi e selvaggi nella storia del metal. Una canzone scritta da Dickinson, ma in cui si sente la mano del produttore Martin Birch, che aveva sperimentato qualcosa di simile in un brano dei Rainbow.
L’aspetto pazzesco di questo album, è che al termine di una traccia come Powerslave, cuspide della musica, ne parte un’altra altrettanto meravigliosa: i 13’36” di The Rhyme of the Ancient Mariner rappresentano, nel 1984, un atto sovversivo nel panorama culturale; il rock, invece di portare alla perdizione, entra nella scuole a insegnare letteratura. La professoressa d’inglese, in 5° Superiore, attaccò lo stereo alla presa dell’aula, e suonò gli Iron Maiden per far immergere i suoi studenti nella ballata di ghiaccio e mostri marini, di navi fantasma e spiriti invisibili, che è il romantico mondo creato da Samuel Taylor Coleridge. Una canzone colossale, onomatopeica, dove l’apertura sincronizzata di tutti gli strumenti ricorda già l’incedere di una chiglia contro le furiose onde dell’oceano. Il resto è arte nella sua forma migliore: un’opera lirica sull’amore universale e la forza del racconto, che si ascolterà nei decenni a venire.
A queste tre canzoni galattiche, come la Cintura di Orione fa parte di una costellazione, se ne aggiungono altre cinque; e la più luminosa è Two Minutes To Midnight – Due Minuti a Mezzanotte; che è l’orologio che calcola, su un arco metaforico di 24 ore, quanto manca a una guerra termonucleare dinamica. “I due minuti sono tutta la notte“, canta Dickinson, mentre elenca gli orrori che si consumano in guerre “tradizionali”, secondo una legge non scritta nota a tutti: la morte degli innocenti è il prezzo perché i soliti noti accumulino denaro e potere.
La parte centrale dell’album, dalla strumentale Losfer Words a Flash of the Blade, a The Duellists e Back in the Village, mantiene alto il livello della musica; in particolare con un’esibizione sbalorditiva dei due chitarristi, Murray e Smith: come se davvero si sfidassero a duello, suonando assoli e riff uno più bello dell’altro. Ma è proprio questa striscia di canzoni che costa il podio, nella mia personale classifica, all’album; che resta uno dei capisaldi della musica rock, questo lo riconosco, ben più di dischi che qui gli stanno davanti. Detto questo, parafrasando Dickinson, resterò sempre “uno schiavo della forza di Powerslave“.
3) THE NUMBER OF THE BEAST – 1982

The Number of the Beast è un head-banger dall’inizio alla fine: mentre lo ascolti, scuoti la testa avanti e indietro, a destra e sinistra; ti metti a fare air-guitar a occhi chiusi, agiti le braccia mimando la batteria; segui tutte le parole, cantando i ritornelli di ogni canzone, fino alla chiusura di Hallowed Be Thy Name, con l’ultimo struggente acuto di Dickinson.
Bruce Dickinson… al suo primo disco con gli Iron Maiden regala una delle più ammalianti prove di canto nella storia del metal; la sua voce aulica, e l’interpretazione passionale in ogni cambio di ritmo all’interno di ogni traccia, definiscono un canone per gli amanti di questo genere.
Sul piano musicale, The Number of The Beast è fitto di una varietà ininterrotta di suoni e melodie, con tempi e accordi da montagne russe; ancora una volta, con l’indiavolato ritmo imposto dal basso di Harris e la batteria di Clive Burr; a cui si aggrovigliano le chitarre gemelle di Murray e Smith, in preda a un furore senza tregua. Di lì a poco, Burr concluderà la sua esperienza con gli Iron Maiden – che con Nicko punteranno a una musica diversa, più epica; ma forse è proprio la presenza di Clive nella line-up dell’epoca d’oro a regalare a questo album un sound così giunglare, così puro e geniale: niente di simile era stato tentato prima; e nulla di paragonabile a The Number of the Beast riuscirà dopo.
Sul piano lirico invece, in questo album i Maiden coltivano il discorso aperto con Killers: creare cioè un album concettuale. E in The Number of the Beast, dalla lettura che ne faccio io, il tema è la ricerca della libertà nel senso ampio dell’espressione.
Libertà intesa come fuga dalla morte per mano di invasori; ecco l’opener Invaders, sui raid Vichinghi nei villaggi lungo le coste inglesi, e la ricerca della salvezza sulle colline. Immagini ridondanti, riproposte addirittura nel titolo, in Run to the Hills: un pezzo che conquista sin dal primo ascolto; una poema sul genocidio dei nativi americani durante la colonizzazione “dell’uomo bianco”:
“[…] but many came, too much for Cree / Oh will we ever be set free?” – […] ma molti vennero, troppi per il Cree / Oh, riusciremo mai a tornare liberi?”
La libertà intesa come fuga da un villaggio-prigione, dove una burocrazia sconosciuta ti leva addirittura l’identità e il passato; è la storia in The Prisoner, dall’omonima serie televisiva, che racconta le privazioni subite da un uomo identificato come il “numero 6”. E’ l’urlo di Dickinson a trasformare questo pezzo in un inno alla libertà:
“Not a prisoner, I’m a free man / And my blood is my own now / Don’t care where the past was / I know where I’m going: out – Non un prigioniero, sono un uomo libero / Voglio vivere la mia vita dove voglio / Non m’importa dov’era il passato / So dove voglio andare: fuori”.
Versi che si elevano a sentimento intimo di tutti gli oppressi e di chi è incarcerato ingiustamente.
“Charlotte, non riesci a uscire da tutta questa pazzia?”: la prigionia delle catene fisiche e mentali che legano una prostituta al suo sfruttatore, e a una vita di perdizione; ecco il tema di 22 Acacia Avenue, seconda parte di 4 dell’epopea iniziata nell’album Iron Maiden. Saprà liberarsi da sola?
La richiesta d’aiuto di un uomo in preda alla psicosi e alla schizofrenia; la ricerca di una liberazione dalle visioni che lo tormentano e che lo stanno portando alla follia. E’ anche così, e non solo come un fumettone, che può essere letta la title track The Number of the Beast.
La fuga perenne da un passato criminale è al centro di Gangland, storia di un uomo che si è costruito una famiglia ma è braccato dai vecchi compagni; e il miraggio della salvezza è ancora lontano: “una volta eri felice di essere libero / l’aria sapeva di buono / e il mondo sembrava tuo amico“. E lì da leggere Gangland, una storia che si dipana come un racconto breve, nella straordinaria interpretazione della band.
C’è poi la seconda traccia, Children of the Damned, complessa sia nel fantastico ordito musicale, che nella decifrazione del testo. La canzone riprende l’omonima pellicola del 1964, in cui si narra di un gruppo di 6 bambini prodigiosi che attraverso la telecinesi assassinavano chi tentava di trattenerli contro la loro volontà, o peggio li attaccava; alla fine, rimangono uccisi da un esplosivo piazzato nel loro rifugio, ma detonato per errore dalle autorità. Tuttavia Harris potrebbe aver trovato ispirazione anche in Children of Hiroshima, docu-film giapponese del 1953 che racconta le storie drammatiche dei sopravvissuti all’olocausto nucleare. Le morti e le sofferenze descritte nel testo assomigliano molto a quelle inflitte ai cittadini giapponesi allo scoppio delle bombe atomiche. C’è un verso, poi, molto forte:
“He is dust on the ground / What did we learn? – E’ polvere sul pavimento / Che cosa abbiamo imparato?”
La liberazione dai rischi posti dall’arsenale atomico è un tema ricorrente nei testi degli Iron Maiden.
E infine l’impossibile fuga dalla forca, nella mitica Hallowed Be Thy Name – Sia Santificato il tuo Nome. Gli Iron Maiden ci accompagnano lungo gli ultimi passi di un condannato a morte, il quale vede la sua vita naufragare; ma ha un ultimo sussulto, la speranza che ci sia una libertà dopo la morte:
“And though the end is near I’m not sorry / Catch my soul, it’s willing to fly away – E per quanto la fine sia vicina, non sono dispiaciuto / Afferra la mia anima, vuole volare via”.
Un brano grandioso, che diventa potente condanna per la più infernale delle pratiche umane: l’omicidio di Stato, spesso inflitto da individui che si dichiarano timorati di dio.
The Number of the Beast è un album che si ama istintivamente; ma dopo un’approfondita analisi, offre addirittura maggiori motivi per essere apprezzato come uno dei capolavori assoluti dell’heavy metal.
2) A MATTER OF LIFE AND DEATH -2006

Solo dopo parecchi anni mi sono accorto della sua esistenza; e ai primi ascolti lo percepivo come una parete sonora che non mi diceva nulla. Poi i primi ripensamenti, e la grande crepa aperta dai bagliori emanati in Brighter Than a Thousand Suns. Alla fine mi sono arreso alla grandezza di questo album riflettendo sull’ultima traccia, The Legacy: una parola traducibile con eredità, ma che in inglese ha un significato più ampio: quello che si è stati capaci di fare, e che si lascia alle generazioni future. Ecco una stanza della canzone, estrapolata dal resto della “poesia”:
“Take the world to a better place / given to all the golden sons just a little hope / Just think what a legacy / you now… will leave – Fai del mondo un luogo migliore / avresti potuto offrire a tutti i figli d’oro una piccola speranza / Prova a pensare che eredità / ora ti lascerai alle spalle.”
Questa è l’accorata chiusura di un album parzialmente concettuale sulla guerra e la religione; due tematiche in alcune tracce direttamente correlate tra loro, che fanno di A Matter of Life and Death un’opera di impegno civile, oltre che di indagine umana. Se è vero che le due questioni hanno sempre fatto parte della narrativa maideniana, qui si coglie una tensione quasi politica.
Il disco uscì nel 2006, a un anno di distanza dagli attacchi terroristici di Londra firmati da Al Qaeda, ala militare dell’Islam fondamentalista; un mattatoio che riaprì le fresche cicatrici dell’11 Settembre e di Madrid. Quando gli Iron Maiden scrissero l’album, poi, la guerra in Iraq era all’apice: il bollettino da quelle lande occupate da truppe occidentali riportava di massacri, torture, armi di distruzione di massa, autobombe.
Guerra e religione sono le problematiche che definiscono i primi anni della decade del millennio: gli Iron Maiden le racchiudono in The Legacy con liriche potenti; nel brano si accusa un “fondamentalista” di aver tradito le giovani generazioni, incamminandole verso progetti di distruzione; ma non è il solo colpevole: è un’epoca, e una società intera, che la band inglese mette sul banco degli imputati:
“[…] la morte viene da tutte la parti / sta diventando uno stile di vita / […] Perchè alcuni, semplicemente, non vogliono la pace”.
Nota a margine: nel brano ci sono tre linee vocali per tre ruoli diversi; artificio che chiarisce perché una band con Dickinson come cantante può aspirare a scrivere testi simili a sceneggiature.
Prendendo spunto da questo brano, lungo 9’24”, si può analizzare lo schema sonoro che ricorre nei cinque pezzi su dieci che a mio parere sono straordinari: un intro acustico melodico, seguito da una tensione musicale in crescendo; nel mezzo, cambi di ritmo che sfociano in un climax fatto di acuti canori, furiose accelerazioni e assoli spettacolosi; a cui seguono i ritornelli, o stanze che risolvono la storia narrata; infine la chiusura, che riprende la melodia dell’intro.
E’ con The Legacy che ho cominciato a chidermi: Che cosa stanno cercando di dire gli Iron Maiden? Gente come Harris, Dickinson, Smith, che in carriera hanno scritto capolavori, che cosa vogliono comunicare con questo album? Una risposta è arrivata quando ho scoperto che nel tour promozionale lo hanno suonato per intero; come a dire: questo fa parte della nostra eredità.
E’ però in For the Greater Good of God, l’ottava traccia, che la grandiosità del progetto di questo album, e della sua finalizzazione, è a portata d’orecchio; sia sul piano lirico che su quello musicale: un brano di 9’25”, che si apre con una splendida stanza, partendo dai primi due versi:
Are you a man of peace / or man of holy war / Too many sides to you / don’t know which any more – Sei un uomo di pace / o uomo da guerra santa / Troppi schieramenti ti vogliono / Non sai più nemmeno in quale stai”
Un’opera di poetica cinematografica, talmente sono verosimili le dinamiche e le immagini descritte. Durante la parte strumentale, si ha la sensazione di salire sul palmo di mano di un gigante, trasportati ad altezze dove è possibile vedere le città sventrate dalle bombe, e intere regioni a fuoco, percorse da eserciti e profughi.
Un altro pezzo emozionalmente devastante è The Longest Day, la quinta traccia, sullo sbarco in Normandia degli Alleati durante la II Guerra Mondiale.
“How long on this longest day / ‘Till we finally make it through – Quanto dura questo giorno più lungo? Quando finalmente arriveremo alla sua fine?”
Versi recitati come un mantra, troppo potenti per rimanere intruppati nel racconto militare: diventano metafora di ogni persona che prega perché l’orrore della guerra finisca. Al tempo stesso, ci connettono nella testa di quei giovani che il 6 giugno 1944 furono trasportati dall’Inghilterra verso il continente europeo occupato dai nazisti.
All’inizio di quei 7’49”, ci ritroviamo imbarcati sui mezzi anfibi, seduti accanto ai soldati che vomitano dalla paura. Sotto i colpi di cannone sparati dalle scogliere, rimbombi prodotti dai tamburi di Nicko, ci lanciamo nell’acqua, correndo verso la spiaggia:
“Valhalla waits, valkiryes rise and fall / Warriors tombs, lie open for us all / a ghostly hand reaches through the veil / Blood and sand we will prevail – Il Valhalla ci attende, valchirie si alzano e cadono / le tombe dei guerrieri sono aperte per tutti noi / una mano fantasmagorica si allunga attraverso il velo / sangue e sabbia, ce la faremo.”
Conoscendo la sorte per oltre 10.000 giovani Alleati che persero la vita o rimasero feriti durante lo sbarco in Normandia, toccano al cuore gli assoli di chitarra: suonano come l’accettazione spirituale di un morte in nome della liberazione dal nazi-fascismo. Un pezzo dove però non manca l’esplicita critica a chi governa; perché il soldato, pur pronto al sacrificio estremo, “è lì a prendersi una pallottola per quelli che lì ce l’hanno mandato“.
Una critica ai governanti, ma ancora più radicale perché chiama in causa la natura umana, è nella terza traccia, Brighter Than a Thousand Suns – Più Brillante di Mille Soli; il racconto di come il Progetto Manhattan si appropriò delle leggi dell’universo, arrivando all’energia atomica, ma per scopi militari. L’uomo è stato capace di creare il “gemello malvagio del sole“: un’impresa che “ci ha spaccato in due l’anima”, visto che “il seme atomico viene lacerato in polvere nucleare“
Un testo, Brighter Than a Thousand Suns, stupendo alla semplice lettura; ma che si ascolta incordato a un ritmo irregolare, come l’incontrollabile scontro di atomi, su cui si elevano gli assoli abbaglianti di Gers, Smith e Murray.
Durissimi sono i riff, dopo un inquietante intro, che illividiscono l’atmosfera del quinto capolavoro dell’album, The Reincarnation of Benjamin Breeg: la storia di uno spirito in un limbo di dannazione, che implora una salvezza nonostante, durante il suo “strano viaggio”, abbia commesso “tanti peccati” e accumulato “pesanti colpe”. Un brano a cui gli Iron Maiden hanno legato la figura di Eddie, la mascotte della band; in una storia che s’allaccia vagamente al Peer Gynt di Ibsen, musicato da Edvard Grieg. La voce di Dickinson dona una complessità a un personaggio contraddittorio; e la musica è un viaggio interiore nell’umanità in cerca di redenzione.
Questi cinque pezzi sommati fanno 43 minuti di musica stupefacente; a cui si aggiungono gli altri che mantengono alta l’asticella qualitativa dell’album: a partire da Lord of Lights, che racconta la lotta del Male sulla Terra con un’epica da Paradiso Perduto di John Milton; e la ballatona Out of the Shadows, sull’accoglienza da re o regina che si dovrebbe sempre riservare ai nuovi nati su questa Terra. Ecco poi These Colors Don’t Run, orecchiabile brano sulla vita militare; e The Pilgrim, che parte con un’armonia seicentesca, per poi lanciarsi in assoli feroci alternandoli a un riff celestiale: il pezzo parla delle migrazioni religiose verso il Mondo Nuovo, dove nella wilderness i pellegrini sperimenteranno una vita di patimenti fisici e lacerazioni nella fede.
E infine l’opener: A Different World: la canzone più maideniana dell’album, con un testo che esplicita il rigetto di quel periodo buio di inizio millennio; ma che, letto su un piano diverso, preannuncia come il resto dell’album sarà “differente”:
“Don’t want to be here – somewhere I’d rather be / […] / Tell me what you can hear and then tell me what you see / Everybody has a different way to view the world / I would like you to know, when you see the simple things / To appreciate this life it’s not too late to learn. – Non voglio essere qui – vorrei essere da un’altra parte / […] / Dimmi quello che riesci a sentire e quello che vedi / Ognuno ha un punto di vista differente sul mondo / Vorrei che tu riuscissi, quando vedi le cose semplici / ad apprezzare la vita, non è troppo tardi per imparare.”
A Matter of Life and Death non è un album perfetto; in alcuni punti la linea vocale di Dickinson sembra troppo tirata, come se l’urgenza del messaggio avesse il sopravvento sull’intonazione; e in certi passaggi la produzione non è riuscita ad armonizzare al massimo gli strumenti: una scelta dettata dalla ricerca di naturalezza in sala di registrazione; in preparazione del tour in cui il disco è stato suonato dalla prima all’ultima nota – con risultati strabilianti.
In definitiva, con questo album gli Iron Maiden hanno voluto mettersi in gioco come forse non avevano mai fatto nella loro carriera; e non è un caso che per il titolo si siano ispirati all’omonimo film del 1946: la storia di un pilota della II Guerra Mondiale caduto durante una missione sulla Manica, ma al quale il tribunale del Paradiso ha concesso una seconda chance. La seconda opportunità che la band inglese non ha sprecato; per non restare il fantasma dei vecchi fasti, ma per riconfermarsi, 20 anni dopo, come un idolo della musica globale.
1) SOMEWHERE IN TIME – 1986

La casualità del miracolo Somewhere in Time – Da Qualche Parte nel Tempo, è rivelata in una dichiarazione di Steve Harris: “All’inizio non ci eravamo posti l’obiettivo di scrivere un album concettuale”. Ma alla fine lui e Smith, gli autori degli 8 pezzi, hanno creato un’opera sul “tempo” inteso come dimensione con cui noi esseri umani siamo costantemente in relazione. Un tema filosofico espresso con una musica capace di toccare un diapason interiore segreto: che vibra solo con questi ritmi e melodie; solo con queste linee vocali; solo con questi cori, solo con questi assoli. Un’anima di verità, in questi 51’24” di metallo puro, in cui io mi fondo completamente.
E di anima si parla nell’opener del disco, Caught Somewhere in Time: “presi da qualche parte nel tempo“. Il tempo come se fosse il contenitore della nostra vita terrena: spesso sembra troppo “piccolo” per “contenere” i nostri desideri; si ha la sensazione di non avere abbastanza spazio per autorealizzarsi in tutte le declinazioni in cui ci immaginiamo. Un modo alternativo, però, e “vendere” la propria anima al maligno, perché “il tempo è dalla sua parte“. Fuor di metafora: si può “guadagnare” tempo andando contro la propria coscienza, o i valori condivisi di una comunità: tradire la propria etica rappresenta la scorciatoia per “raggiungere i propri sogni“:
“Make you an offer you can’t refuse / You’ve got only your soul to lose / Eternally…ahaha, let yourself go – Ti faccio un’offerta che non puoi rifiutare / Hai solo la tua anima da perdere / Per l’eternità…ahaha, lasciati andare.”
Scelte che segnano per sempre la nostra vita, “eternamente”, e fanno di noi ciò che siamo e saremo.
Caught Somewhere in Time è un brano di 7’23” che scandisce un ritmo cosmico, a tratti veloce come un raggio gamma; un pezzo ammantato di una atmosfera “futuristica”, fin dall’intro con i sintetizzatori, che accompagna la mente in un viaggio spazio-temporale. Un viaggio che durerà per il resto dell’album.
Il ritmo dell’opener, infatti, è un tessuto sonoro replicato anche negli altri pezzi, orbitanti a una serie di vorticosi riff; e percorsi da stringhe di assoli e linee vocali che sembrano intricarsi e sovrapporsi senza soluzione di continuità. Ecco perché per omogeneità e compattezza, Somewhere in Time è accostabile a Piece of Mind.
Nella seconda traccia dell’album, il tema è implicito nel titolo: Wasted Years: ritrovarsi a rimuginare su tutti gli anni sprecati, perché non si è affatto felici di come si sta vivendo. E genera ansia l’idea di avere troppo tempo nelle mani, “Too much time on my hands“; per la paura di non riuscire comunque a cambiare il corso della propria vita. Ecco però la reazione, nel melodioso ritornello:
“So understand / Don’t waste your time always searching for those wasted years / Face up…make your stand / And realize you’re living in the golden years – Quindi cerca di capire / Non perdere tempo sempre alla ricerca di quegli anni sprecati / Alza la testa…prendi coscienza / che stai vivendo i tuoi anni d’oro.”
La terza traccia, Sea of Madness, è un viaggio nel tempo, in un futuro indefinito che lascia una grande tristezza; “I miei occhi vedono, ma non riescono a crederci […] è follia, il sole non risplende su quel Mare di Pazzia, e non c’è vento a gonfiare le tue vele“. Un paesaggio che lascia al viaggiatore un cuore pesante, mentre ritorna da noi per avvertirci che già oggi “stiamo seguendo il corso di un fiume che ci porterà verso un domani di rovina e dolore“.
La quarta traccia, fin dall’esoterico intro, ti immerge nella dimensione metafisica tra la vita e la morte; lì dove ti accoglie, con una grande luce alle spalle, una schiera celeste: che vuole accompagnarti nella Terra Promessa, dove il tempo non esiste, ma solo l’eternità. La paura tutta umana che scatta, però, è quella che l’anima fluttui per sempre in un vuoto indeterminato; ecco quindi Heaven Can Wait – Il Paradiso Può Attendere: il desiderio di una seconda possibilità, il ritorno sul concretissimo pianeta Terra per rituffarsi nella vita.
La quinta traccia, per quanto mi riguarda, è un chiaro capolavoro di Harris: vivere ogni passo del presente dando tutto quello che hai, pur di fronte agli ostacoli che la vita ti mette davanti; e che spesso ti trovi a dover superare solo con le tue forze. E’ la filosofia implicita a The Loneliness of the Long Distance Runner – La Solitudine del Maratoneta, brano ispirato all’omonimo romanzo di Alan Sillitoe: un adolescente in riformatorio ritrova una libertà interiore correndo le corse campestri, sebbene debba vincere per una scommessa del Direttore del carcere. La potenza del messaggio è racchiusa in una stanza che Bruce Dickinson, sopra il compatto incedere strumentale della band, rende immortale:
I’ve got to keep running the course / I’ve got to keep running at alla cost / I’ve got to keep going, be strong / Must be so determined and push myself on – Devo continuare a correre lungo il tracciato / Devo continuare a correre a ogni costo / Devo continuare ad andare avanti, sii forte / Devo essere molto determinato e spingere me stesso più il là.”
E’ di Smith l’altro chiaro capolavoro dell’album, Stranger in a Strange Land – Straniero in una terra strana: ispirata alla spedizione capitanata da John Franklin, nel 1845, per trovare il passaggio a nord-ovest attraverso il Mare Artico. Bloccati dal ghiaccio, che chiuse ogni via navigabile, alcuni superstiti tentarono la traversata a piedi: perirono tutti, i loro corpi ritrovati decenni dopo, cristallizzati in quell’eternità di gelo. I versi, però, presi come metafora esistenziale, puntano a concetti alti:
Was many years that I left home and came this way / I was a young man full of hopes and dreams / […] / What became of the men that started / All are gone and their souls departed / Left me here in this place / So all alone – Sono molti anni che ho lasciato casa e sono giunto per questa via / Ero giovane pieno di speranze e sogni / […] / Che cosa accadde degli uomini che partirono / Tutti andati, e le loro anime distaccatesi / Mi hanno lasciato qui in questo posto / Così tutto solo”.
Lo smarrimento dell’esploratore negli ultimi momenti della sua esistenza, assomiglia ai conti che si fanno alla fine del nostro viaggio terreno: pensando alla nostra giovinezza, alle attese e al nostro percorso, alle scelte giuste e a quelle sbagliate. Il tempo, imperturbabile, continua a scorrere: lasciandoci là in quella landa gelata; e metaforicamente, lascia di noi, se qualcuno volesse raccoglierla, la memoria delle nostre esistenze.
Ed è su questo concetto di Stranger in a Strange Land che gli Iron Maiden nel 2000 hanno raccolto la memoria delle loro imprese; “No Brave New World“, cantava nel 1986 Dickinson: Nessun Mondo Nuovo. E invece, l’album che suggella il ritorno alla formazione dell’epoca d’oro si intitolerà proprio Brave New World: il tempo non li ha congelati nei fasti del passato; gli Iron Maiden sono riusciti a raggiungere il loro Mondo Nuovo.
Eppure, ed è il tema della settima traccia, lo scorrere del tempo è un mistero; De-ja Vu – l’espressione francese che definisce la strana sensazione di aver già vissuto in un istante presente: l’inganno “di sapere quello che sta per accadere, come se (la realtà) fosse già predefinita” in uno schema che a noi sfugge.
Oppure il tempo, e qui siamo nell’ottava e ultima traccia, ci è precluso per un destino che tocca a tutti; la morte che a volte coglie nel momento meno atteso, e non guarda in faccia nessuno. Alexander The Great (356-323 A.C), con il passo musicale di una lunga marcia trionfale, ripercorre le imprese di Alessandro Magno; il quale giunse ai confini del mondo conosciuto nel suo disegno di gloria, e sete di potere e avventura:
Alexander the Great / His name struck fear into the hearts of men / Alexander the Great / Became a God amongst mortal men – Alessandro Magno / Il suo nome incuteva paura nel cuore degli uomini / Alessandro Magno / Diventò un Dio fra i mortali uomini.”
Eppure bastò una febbre – così si narra – per stroncare a soli 33 anni il più grande conquistatore di tutti i tempi. Un inno maideniano alla grandezza degli esseri umani, vittime però della caducità della vita.
E’ la riflessione finale sulla dimensione del tempo, che per noi umani ha sempre una fine terrena, ovunque ci troviamo: dalla Babilonia del III secolo A.C., fino alle soglie del III millennio D.C..
E in conclusione, rivolgendo uno sguardo sul futuro, non resta che un dubbio: fino a quando si ascolteranno gli Iron Maiden? I loro dischi arriveranno alle orecchie dei giovani del XXII secolo?
Intanto una certezza l’ho raggiunta: quell’amore al primo ascolto ha mantenuto tutte le sue attese; tra alti e bassi, abbandoni e tradimenti. La storia tra me e la band inglese, dopo oltre trent’anni, è ancora viva e bellissima.
Di Cristiano Arienti
In copertina: gli Iron Maiden e le cover di alcuni album
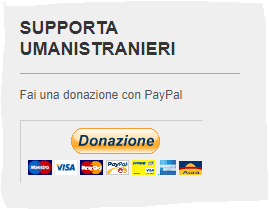
Iron Maiden Ranked – Loudersound



Carissimo Cristiano hai fatto un lavoro pazzesco meraviglioso!!! Complimenti grandissimi. Mi hai fatto rivivere il mio luglio 1981 in UK quando scopro il metal e mi compro usato il primo album dei nostri Irons ! Tutto ciò non ha prezzo sai …tutti i dischi commentati… hai fatto un lavoro Epico come i brani dei nostri Irons
Lo conserverò e rileggerò tante volte, ho pure dei cd da acquistare che saltai appunto nel periodo di crisi, ma anche mia con distacco da musica e libri, periodo che poi passò
Marco Leofrigio Up the Irons For Ever
Grazie Marco. Per scrivere un pezzo del genere, “epico”, sono partito sí dalla mia esperienza e dai miei gusti; ma anche dal riconoscere che gli Iron Maiden sono degli artisti veri, e con i loro lavori veicolano messaggi che piú o meno implicitamente arrivano con la musica; ma che qui ho voluto renderli piú espliciti e visibili – secondo le mie opinioni e le mie interpretazioni.
Se lo meritavano, al di lá che una canzone possa essere più o meno bella, o un album piú o meno riuscito.
E sono contento che il pezzo faccia rivivere bei ricordi ai fan che li hanno scoperti negli anni ’80 e ’90.