Trump, una visione di Medio Oriente realizzata
Il Medio Oriente come il cubo di rubik: un enigma che Donald Trump s’è trovato in mano sin dal primo giorno di Presidenza. Non a caso il tema è stato centrale nei dibattiti elettorali 2015-2016, in tutte le sue diverse facce: prima fra tutte, lo Stato Islamico (Isis), con la barbara legge del sangue calata da Raqqa, in Siria, fino a Mosul, in Iraq, ed esportata dall’Asia all’Africa fin dentro al Bataclan di Parigi e la metropolitana di Bruxelles. Una questione che all’epoca, insieme al tentativo di rovesciare il regime siriano di Assad, incendiava tutto il Medio Oriente, precipitato in una guerra regionale fra Iran e Arabia Saudita, con Russia, Turchia e Israele partecipanti attivi. La presenza degli Stati Uniti nell’area restava ambigua ma ingombrante: a partire dal sostegno a gruppi ribelli siriani, fra loro anche filo-qaedisti; e la difesa delle basi militari in Iraq, frutto del destabilizzante e costoso intervento voluto da George W. Bush nel 2003.

Nelle primarie repubblicane Trump si misurò proprio con il fratello di Bush, Jeb; e poi con la candidata democratica Hillary Clinton, che da Segretario di Stato dell’Amministrazione Obama-Biden aveva armato i ribelli siriani dalla fine del 2011. Un’insurrezione sequestrata nel 2012-2013 dagli estremisti islamici; e da Abu Bakr Al-Baghdadi, leader del sorgente Isis. Operazioni finanziate, all’epoca, dalle monarchie del Golfo, come ammesso dalla Segretario di Stato Clinton in una comunicazione privata pubblicata da Wikileaks; e facilitate dalla Turchia, che permetteva il travaso di foreign fighters in Siria.
La mutazione della rivolta siriana si sommava al fallimento di altre primavere arabe: dall’Egitto, svegliatosi nell’incubo della sharia, alla Libia, piombata nel caos di una guerra civile – con il dilagare dell’Isis, e la simmetrica ascesa del Generale Haftar. Uomini forti e gruppi radicali lesti a prendersi spazio e potere, sgambettando i primi passi di nascenti democrazie.
L’Isis ha rappresentato la tragica fine dei sogni di libertà e giustizia, ispirati anche dal discorso di Barack Obama al Cairo, nel 2009: un appello ai popoli arabi che non ha avuto successo. Lo stesso Presidente Usa, come riportato da The Atlantic in un ritratto dell’aprile 2016, ha dovuto ammettere:
“Il medio Oriente non può essere sistemato; né sotto la mia Presidenza, né in un’intera generazione.”
Implicitamente, quindi, tirò in causa la sua Segretario di Stato Hillary Clinton, all’epoca candidata Democratica; e il suo Vice-Presidente Joe Biden, l’attuale candidato Democratico; il quale, post-11 Settembre, da Presidente della Commissione Esteri del Senato, lavorò affinché il Congresso Usa appoggiasse la guerra unilaterale in Iraq. E sempre Biden, nell’agosto 2013, mise pressione per un intervento militare Usa su Damasco, dopo l’attacco chimico a Ghouta: mentre Obama tergiversava, Biden si espose pubblicamente addossando le colpe su Assad – una ricostruzione a cui il Presidente Usa non aveva pienamente creduto. Questo, e il timore di invischiare gli Usa in una nuova guerra mediorientale, convinsero Obama a non dare il via libera al cambio di regime in Siria; gli Usa cedettero al piano elaborato in extremis dalla Russia, che laggiù ha basi militari: coinvolgere le Nazioni Unite nella distruzione dell’arsenale chimico di Assad.
Un nuovo attacco chimico in Siria, a Khan Shaykun nell’aprile 2017, è stato il primo test dell’Amministrazione Trump nella regione; ancora una volta Damasco è accusata di aver usato gas nervino. Pressato da più parti, il Presidente Usa ha ordinato una scarica di missili su una base militare vicino a Oms, provocando vittime e danni; ma non alle forze russe in Siria, preventivamente avvertite.
Damasco si è limitata a condannare il bombardamento, ma è rimasta in attesa degli eventi; alla luce del cambio di strategia Usa sulla Siria, pubblicamente annunciato nelle settimane precedenti. Nel marzo 2017 il Segretario di Stato Rex Tillerson prima, e l’Ambasciatrice all’Onu Nikki Haley poi, avevano dichiarato che rovesciare il regime di Assad non era più una priorità. La Casa Bianca, subito dopo, aveva dettato il vero obiettivo: sradicare lo Stato Islamico, come promesso da Trump.
In quei giorni il Presidente Usa aveva incontrato a Washington il Principe ereditario Mohamed Bin Salman, nuovo uomo forte di Ryadh – che in Trump troverà un alleato di ferro. I due cominciano a ridisegnare il Medio Oriente a partire dall’annientamento dell’Isis; scatta così l’avanzata definitiva su Raqqa, in Siria: un’offensiva aerea della coalizione a guida Usa, con truppe dell’esercito siriano, più i kurdi, sul campo. Contemporaneamente, si finalizza la presa di Mosul, in Iraq; anche con il decisivo supporto dei pasdaran iraniani del Generale Kassem Suleimani – il quale era stato il vero baluardo di Baghdad, più che le truppe Usa, di fronte all’avanzata dell’Isis tra il 2014 e il 2015.
Tuttavia è proprio su Tehran che gli Usa fanno perno per accelerare il processo di cambiamento del Medio Oriente; con Trump che ha dato seguito a un’altra promessa elettorale: sfilarsi dall’Accordo sul nucleare iraniano. Un traguardo dell’Amministrazione Obama, nell’ottica di pacificazione della regione: fu raggiunto nell’agosto 2015, dopo una lunga trattativa condotta dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. L’acquisizione del nucleare da parte di Tehran, pur a scopi pacifici, non è accettato da Arabia Saudita e soprattutto da Israele, guidato da Benjamin Netanyahu – altro grande alleato di Trump.
Il ritiro Usa dall’Accordo si è concretizzato nel maggio 2018, dopo la definitiva presa di Aleppo da parte dell’esercito siriano, supportato dall’aviazione russa. Un’operazione andata avanti nonostante in aprile l’Occidente avesse accusato Assad di un nuovo attacco chimico, a Douma; anche in questo caso una coalizione a guida Usa ha reagito bombardando obiettivi militari in Siria; senza però scatenare reazioni di Damasco e Mosca. Dopo 7 anni, infatti, raggiungevano il loro obiettivo: schiacciare ogni opposizione, compresa la rete dei ribelli siriani islamici e filo-qaedisti sunniti. Una vittoria, in primis, di Kassem Suleimani: negli anni in cui il regime siriano era stato in bilico – con “Assad must go” ripetuto nelle capitali occidentali – i pasdaran iraniani avevamo protetto i vertici di Damasco; e supportato il raffazzonato esercito siriano nel riconquistare le principali arterie e città del Paese.
Conclusa la fase di sradicamento dell’Isis e dei ribelli filo-qaedisti, ne comincia un’altra: è nel 2018 che Israele, con il silenzioso assenso Usa, comincia a bombardare le postazioni iraniane in Siria, smantellando la rete logistico-militare costruita in quegli anni da Suleimani. Netanyahu, di fatto, estende il raggio d’azione israeliano nel sud della Siria per spezzare l’asse fra Tehran ed Hezbollah, il partito di Dio libanese, alleato di Hamas a Gaza .
La reazione di Suleimani, plenipotenziario delle operazioni militari iraniane, non tarda; ed è una risposta anche alle sanzioni Usa contro Tehran, dopo la ripresa dell’arricchimento di uranio oltre la soglia stabilita dall’Accordo del 2015. Dapprima partono attacchi estemporanei alle truppe Usa in Iraq; nella seconda metà del 2019 si intensificano schermaglie intorno alla green zone americana di Baghdad, con il lancio di razzi contro l’Ambasciata. Il Presidente Trump, forte della statura bellica americana, ordina di far fuori Suleimani: il 3 gennaio 2020 un missile teleguidato si abbatte su Baghdad, uccidendo il Generale iraniano e i suoi più stretti collaboratori. E’ il segnale che gli Usa non tollerano più le mire egemoniche iraniane in Medio Oriente; soprattutto in Iraq.
Nel giro di pochi mesi è la seconda uccisione mirata targata Usa che scuote la regione. In Siria il 26 ottobre 2019, sul confine con la Turchia, era rimasto ucciso in un raid americano Abu Bakr Al-Baghdadi. Il leader dell’Isis, si sospetta, è stato abbandonato da Ankara. In cambio, il premier turco Erdogan avrebbe avuto il via libera americano a invadere il nord della Siria, per smantellare il Rojava, territorio autonomo dei Kurdi. L’offensiva, partita a metà ottobre, ha appianato le tensioni fra Turchia e Trump, montate proprio per l’alleanza Usa con il Rojava; e ha cancellato, per l’ennesima volta, il sogno di un Kurdistan federato e indipendente.
E’ nella memoria collettiva la resistenza di Kobane, a pochi chilometri da un’indifferente Turchia, di fronte ai tagliagole dell’Isis: le giovani truppe del Rojava hanno imposto pesanti perdite tra le fila del califfato, nel suo periodo di massima espansione.
Il tradimento dei Kurdi risalta un aspetto dell’approccio di Trump: sacrificare l’asset più debole per realizzare i propri piani; come è stato, del resto, per i movimenti pro-democrazia in Egitto: Trump appoggia in modo incondizionato il dittatore Al-Sisi. Per quanto riguarda la Libia, una volta azzerato il rischio Isis, il Presidente Usa si è disinteressato della guerra civile, consapevole che è un affare mediterraneo, più che mediorientale.
Questo pragmatismo si è esaltato con il processo di pace fra Israeliani e Palestinesi: ignorando completamente le richieste, storiche o contingenti, degli ultimi; e tranciando il dialogo anche con moderati come Abu Mazen, leader della ANP (Autorità Nazionale Palestinese). Il piano di due Stati indipendenti è ormai carta straccia, con Israele che ha allargato la colonizzazione in Cis-Giordania, condannando sempre più i Palestinesi all’apartheid.
Tra il 2019 e il 2020 Trump ha esposto il suo Piano di Pace, che calpesta non solo le aspirazioni dei Palestinesi, ma vìola risoluzioni Onu. Contro ogni pronostico, dopo pochi mesi, Israele è stato riconosciuto da Emirati Arabi Uniti, Bahrein e Sudan; con un volo di Stato di Tel Aviv che ha sorvolato, per la prima volta, lo spazio aereo saudita: preludio di una futura relazione diplomatica fra due storici avversari. I Palestinesi sono stati messi all’angolo da Trump, con i loro protettori iraniani, a loro volta, in forte crisi.
Questi risultati, all’apparenza sbucati dal nulla, sono il frutto della strategia di Trump nella regione; resa digeribile da concessioni ai “nemici”, come Assad e Putin; e con inaspettate operazioni diplomatiche e militari in favore degli alleati. A metà 2018, il Presidente Usa ha mantenuto la promessa di spostare l’Ambasciata Usa a Gerusalemme; imponendo una direzione al processo di pace Israelo-Palestinese difficile da invertire in tempi brevi. La stessa uccisione di Suleimani è stata una dimostrazione nei confronti dell’Arabia Saudita: per tutto il 2019 Ryadh è stata nel mirino di attacchi militari e terroristici sullo sfondo della guerra con lo Yemen, coperti, se non proprio organizzati, da Tehran.
La credibilità del Presidente Usa si è rivelata anche con il suo personale impegno nella crisi del prezzo del petrolio dello scorso marzo, con la “guerra” fra Russia e Arabia Saudita; con in ballo la filiera produttiva dello shale americano, Trump si è fatto intermediario fra Mohamed Bin Salman e Vladimir Putin per risolvere una crisi che poteva riaccendere il Medio Oriente.
La soluzione di Trump all’enigma mediorientale non è mai stata il disimpegno militare, sebbene sia riottoso all’idea di guerre campali; le basi irachene e i pozzi petroliferi strappati all’Isis in Siria, d’altronde, rimangono roccaforti Usa intoccabili. In questi quattro anni Trump si è proposto come un ascoltatore da posizione di forza; ha fatto intendere di avere sempre pronto l’indice: sia per premere il grilletto per interventi mirati, sia per indicare la via che porti al compimento della sua visione.
Non è detto che i risultati di Trump siano risolutivi o durevoli; soprattutto perché tengono poco conto di fattori essenziali: la sorte dei rifugiati di guerra, i diritti civili calpestati per centinaia di milioni di persone; le rivendicazioni etniche andate deluse; l’impunità e la sete di potere degli uomini forti; il fanatismo religioso che avvelena la politica; la forza e l’orgoglio iraniano; i rischi legati al petrolio con la transizione energetica all’orizzonte. Tuttavia è un Medio Oriente più stabile, in un quadro pur sempre complesso, rispetto al fiammeggiante paesaggio del 2015-2016; che potrebbe rinfocolarsi, qualora un’eventuale Amministrazione Biden-Harris decidesse di cambiarne di nuovo la faccia.
di Cristiano Arienti
In copertina: il Presidente Usa Donald Trump
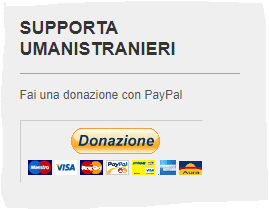
Fonti e Link utili:
Da Obama alla Clinton: gli Usa in Medio Oriente e le conseguenze per l’Europa.
