Libertà di parola: se mi cancelli ti ascolto
“Ti cancellerò, e cancellerò il tuo canale se non parli contro la discriminazione razziale, e del tuo privilegio di bianca”. La minaccia alla youtuber americana SouthernAsmr è arrivata insieme a un’accusa terribile: “sei una razzista bigotta”; a lanciarla pubblicamente, un’altra youtuber, con un seguito di oltre 1 milione di persone. Qual’era la colpa di Mary, che sul suo canale SouthernAsmr propone solo contenuti di rilassamento e svago? Un post su Instagram in cui spiegava che, nonostante la tirassero per la giacchetta da più parti, non avrebbe commentato la morte di George Floyd, afro-americano ammazzato lo scorso 25 maggio durante un controllo di polizia. “Sui miei canali social”, ha ribadito, “vige una regola: non parlare di politica o religione.”

Tra maggio e giugno, nel mezzo di una presa di coscienza sul razzismo strutturale negli Usa, quella posizione per alcuni è suonata intollerabile. Da quel momento Mary è stata sommersa da insulti e cattiverie; e minacce che hanno spinto la youtuber a infrangere la sua stessa regola, e postare un video intitolato “Ok, let’s talk – va bene, parliamo”: fra magoni e pianti, la donna, una madre single lavoratrice, si è difesa: “non sono una razzista, non sono una bigotta; George Floyd è stato ammazzato in modo orribile e i colpevoli meritano la massima pena. Sono solidale con le manifestazioni, ma condanno i saccheggi e i vandalismi verificatisi anche nella mia città, in North Carolina. La brutalità poliziesca è un problema enorme, complesso e ramificato in questo Paese, e non sarà certo un mio commento a risolverlo”.
Forzata a parlare di Floyd e del clima di violenza, Mary ha poi spiegato il vero motivo del video: raccontare dei messaggi minatori ricevuti, alcuni con l’allusione di conoscere i movimenti suoi e dei suoi figli. “Oggi sono andata dalla polizia a denunciare questi account; e chi mi sta minacciando – ha detto Mary visibilmente prostrata – sappia che non sono impreparata; se pensate di fare del male ai miei figli o a me, per voi non finirà bene.”
Due anni fa la ricercatrice dominicana Raquel Rosario Sanchez, invece, si è rivolta ai vertici dell’Università di Bristol, Gran Bretagna: denunciava le pressioni ricevute da attivisti per i diritti dei transessuali durante attività accademiche; a guidarle, una transdonna sua collega. Sanchez temeva per la sua incolumità, in un clima di intimidazione: picchetti, minacce on-line e manifesti contro la sua persona. Tutto era partito nel 2018: Sanchez, borsista che studia la violenza sulle donne, fu invitata a presiedere una conferenza di Woman Place UK (WPUK), associazione che difende i diritti della donna su basi biologiche, e per questo definita TERF (Trans-exlusionary radical feminist) e transfobica.

Quindi Sanchez è stata inquadrata come persona che diffonde odio, e inadatta per l’Università di Bristol. Lo scorso anno, cadute nel vuoto le sue lamentele, e invitata a non diffamare coloro che l’hanno presa di mira, la ricercatrice ha rilasciato dichiarazioni pubbliche al Sunday Times e alla BBC: ormai, ha confessato, mi sento ogni giorno un bersaglio per le mie opinioni e le mie ricerche. Per ritorsione, l’Università di Bristol, andando contro il positivo giudizio della relatrice di Sanchez, non le ha rinnovato la borsa di studio – pagatale in seguito dal suo Governo. Sanchez è ancora oggetto di accuse di transfobia, e di una campagna di boicottaggio; dopo due anni, si è decisa a denunciare l’Università di Bristol per non averle garantito un clima sereno sul posto di lavoro.

Target di una campagna online e a mezzo stampa lo è stato anche Benny Fredriksson, ex Direttore artistico del Kulturhuset Stadsteatern, centro culturale di Stoccolma. Si è sviluppata a cavallo tra il 2017 e il 2018, in pieno #MeToo – movimento di risveglio delle donne contro le molestie sul lavoro; la colpa di Fredriksson, sposato con figli, non era nemmeno un’aggressione a sfondo sessuale, ma un modo di relazionarsi giudicato abusivo e umiliante: fra le accuse più gravi, avrebbe imposto a una collaboratrice di scegliere fra la gravidanza e il ruolo in uno spettacolo. “Un piccolo Hitler”, così un’anonima l’ha apostrofato sulle pagine dei giornali. Rassegnate le dimissioni, l’ex Direttore è stato sottoposto a un’indagine disciplinare, parallela a una quotidiana criminalizzazione della sua persona. Il risultato preliminare non ha trovato riscontri ai pettegolezzi: le accuse non erano mai avanzate per vie ufficiali; non è bastato però a fermare la mano suicida di Fredriksson, senza lavoro, con la reputazione rovinata, e caduto in depressione.

Si è levata la vita a soli 23 anni anche l’americana Mercedes Grabowski, stella dell’industria pornografica, conosciuta con lo pseudonimo August Ames; un gesto arrivato – in un periodo già difficile – dopo giorni di insulti e minacce in seguito a un tweet: Ames avvertiva le colleghe di aver appena rifiutato di girare con un attore bisessuale, senza nominarlo, privo di certificato di negatività a malattie trasmissibili sessualmente; una denuncia poi allargata, in generale, a quella particolare categoria nell’industria del porno. Dipinta come omofoba, è stata pressata a scusarsi con la comunità gay; “oppure – un attivista gli ha scritto – puoi anche ingoiare una pillola di cianuro”. “Fottetevi tutti”, è stato l’ultimo messaggio della giovane, prima di impiccarsi.
La cultura di cancellare una persona
Ognuna di queste storie ha in comune un individuo additato sulla pubblica piazza (fisicamente, a mezzo stampa o sui social media), reo di aver espresso opinioni riprovevoli, o di aver commesso qualcosa di intollerabile, e quindi descritto come una persona orribile. Di solito, quando si finisce nel mirino, è consigliabile ammettere di aver sbagliato e scusarsi, se arrivano richieste di fare un passo indietro dal proprio ruolo professionale.
In realtà l’ammissione di colpa potrebbe non bastare per calmare quella che Richard T. Ford, professore di legge a Stanford, definisce la “soddisfazione emozionale”: ovvero un senso di giustizia per opinioni o comportamenti che sfiderebbero un codice morale comune a gruppo di persone. Spesso si tratta di una massa critica che, amalgamata politicamente, o coalizzatasi all’occasione, non esprime per forza una maggioranza di pensiero; può però condizionare la vita o la carriera di chi violerebbe quei valori. Non si placa con il presunto colpevole che ammette la colpa, o si scusa con la presunta vittima: è la punizione che appaga, l’espiazione del singolo di fronte agli indici. Tutto questo, per la scrittrice Margareth Atwood, avviene in un’aula fittizia dove la massa critica rappresenta accusa, giudice e giuria; spesso non è concessa nessuna difesa, e le attenuanti sono irrilevanti. Si tratta di una moderna caccia alle streghe, così l’ha chiamata l’autrice canadese in un saggio del 2018.
Le scuse, spesso, arrivano immediatamente: la posta in gioco, al di là del bloccare la violenza verbale e le minacce, è la rovina di una reputazione e di una carriera, assi portanti di una vita stabile. Se non sono offerte come una piena “confessione”, accompagnate da un atto di contrizione, le scuse infiammano ancor di più la pira. In fondo la persona finitaci sopra è già cancellata della propria storia e della propria identità; di lui, o di lei, rimane un pagliericcio: simbolo del razzismo, dell’abuso patriarcale e della molestia sessuale, dell’omofobia, della transfobia, dell’estremismo politico. L’ostracizzazione non è più solo l’atto della giustizia sociale – a volte ribaltata nei tribunali della giustizia ordinaria: è una purificazione collettiva; non importa più che la nostra convivenza si regga, come ha sottolineato Atwood, sul giusto processo.
La Atwood, autrice di un caposaldo del femminismo come il Racconto dell’Ancella, scrisse quel saggio perché lei stessa fu chiacchierata durante il #MeToo, come fiancheggiatrice della cultura predatrice sui luoghi di lavoro. La sua colpa? Nel 2016 aveva firmato una petizione in favore di Steven Galloway, un collega della British Columbia University accusato di aggressioni sessuali e molestie. Galloway fu poi licenziato, sebbene le accuse vennero giudicate infondate durante la medesima indagine disciplinare; per questo l’Università ha dovuto risarcire lo scrittore per danni di immagine con 240.000 $.
Tutt’oggi Galloway combatte nelle aule di tribunale per ripulire il suo nome; come stanno facendo decine di uomini tirati in ballo – a torto o a ragione – durante il #MeToo: alcuni non hanno più una carriera. Non tutti però, hanno la forza o i mezzi per difendersi: soprattutto se riconoscono non un crimine, ma un comportamento sconveniente o irrispettoso.
La massa però non si ferma di fronte alle giustificazioni né alle scuse di un individuo, tanto meno al suo personale disagio. Questa massa è indistinta, ma non è un’entità astratta: è composta da singoli che agiscono coscientemente, portando avanti un’idea alta di giustizia sociale; si pongono automaticamente su un piedistallo morale. Una delle questioni della cultura della cancellazione, intesa come strumento di progresso sociale, è la proporzione inversa riguardo allo status: più la persona accusata cade in disgrazia, più si eleva l’ammirazione per chi porta avanti le accuse. L’attaccare chi avrebbe violato dei codici morali non resta fine a se stesso, ma sviluppa legami fra persone, in un reciproco incoraggiamento a essere dalla parte della ragione; anche quando la linea di demarcazione fra giusto e sbagliato non è così netta.
L’ex giornalista del Los Angeles Times Jonathan Kaiman nel 2018 fu accusato da due amiche, con un ritardo di anni e mesi, di molestie sessuali; rapporti durante serate alcoliche che però non sembrano costituire reati. L’uomo si scusò pubblicamente nel caso la sua condotta, in retrospettiva, fosse stata giudicata molesta. Quell’atto di contrizione non bastò a evitargli la cancellazione: era diventato “radioattivo” pur in assenza di condanne o azioni disciplinari. Se Kaiman ha dovuto cambiare mestiere e Paese, la sua accusatrice, Felicia Sonmez, è stata assunta come corrispondente politica del Washington Post: non è mai ricorsa alle vie legali, ma contro il suo presunto aggressore aveva sfoderato un attacco così articolato che la nuova proprietà del Los Angeles Times mise Kaiman alla porta: ormai il suo nome danneggiava l’azienda.
Ancora oggi la reputazione di Atwood è macchiata, nella memoria collettiva, per quella sua presa di posizione, nel 2016, in favore del giusto processo; per un uomo che poi è stato giudicato innocente.
Il timido appoggio espresso nei confronti di Kaiman da colleghi e amici si è ritorto contro di loro: vennero etichettati come maschilisti e “parte del problema”.
E’ l’accusa addossata ai follower di SoutherAsmr: chi riconosceva a Mary la libertà di non commentare la morte di George Floyd, è stato a sua volta gettato nella bolgia dei razzisti.
Quando si espande un simile clima attorno a una persona, diventa difficile perfino solidarizzare. Le dimissioni di Fredriksson furono accettate subito; i suoi datori di lavoro lo lasciarono solo di fronte a un killeraggio; timorosi, forse, che una sua difesa potesse danneggiare l’Istituto di cultura.
La bullizzazione di August Ames fu addirittura un “passatempo” su Twitter. Il gesto estremo dell’attrice lasciò tutti a bocca aperta, e con i pop-corn in mano. Nessuno ha mai pagato per quegli abusi verbali durati per giorni.
L’Università di Bristol non ha mai fatto sentire al sicuro la Sanchez, negandole qualsiasi forma di protezione: la semplice apertura di un’indagine disciplinare sulla sua collega, ha fatto calare l’ombra della transfobia sull’istituzione; figurarsi se poteva deliberare che lei fosse oggetto di una campagna persecutoria.
Negli ultimi anni sono numerosi i casi di scrittrici e accademiche femministe marchiate di transfobia. Donne, perfino attiviste LGBT, che hanno avuto problemi a mantenere incarichi di lavoro, o a pubblicare i loro scritti o distribuirli, o partecipare a conferenze. Il merito delle loro ricerche sulle donne come minoranza è spazzato via, senza nessun tipo di appello, inquadrato come armamentario di odio nei confronti della minoranza trans. Sullo sfondo, il dibattito intorno alla teoria che l’identità di genere soppianti quella basata sul sesso; facendo retrocedere la “donna” da classe politica e biologica a termine ombrello per chiunque si senta tale. L’etichetta di transfobia, o Terf, spesso è usata con la stessa semantica di “suprematismo bianco” – incurante delle femministe critiche dell’identità di genere di origine afro-americana o afro-europea; anche loro vengono escluse da qualsiasi dibattito pubblico – perfino estraneo al femminismo o alla transessualità – e relegate fra gli impresentabili.
“Spazzatura”, ecco come è stata apostrofata Raquel Sanchez dai suoi critici nel perimetro delle attività accademiche.
La ricercatrice dominicana si è espressa così contro l’immobilismo dell’Università di Bristol nell’accordarle misure di protezione: “l’essere bullizzate e molestate per un lungo periodo è un’esperienza spaventosa, ed è altamente deleterio in un ambiente accademico, dove l’apprendere dovrebbe prosperare. […] Credo che ognuno debba essere trattato con rispetto e dignità quando esercita il diritto di diffondere le proprie idee politiche, al di là dell’essere in disaccordo.”
Per essere bullizzata, molestata, e minacciata, alla youtuber Mary è stato sufficiente un “no comment”: è diventato l’invito alla cancellazione della sua persona, e alla distruzione del suo canale youtube; un’attività a cui Mary si è impegnata animo e corpo postando centinaia di video di svago e intrattenimento, e che in cinque anni si è trasformata in un secondo lavoro.
“Conosco il tipo di persona che sono: e non sono un mostro, non sono malvagia”; sono le parole pronunciate da Mary per riprendersi l’identità che le “la massa di vampiri sui social media” le stavano strappando di dosso con accuse infamanti.
Il dibattito sulla cancellazione: difesa della persona o difesa del potere?
La “cultura della cancellazione”, scrive sul Guardian l’attivista di sinistra Billy Bragg, è l’ultima novità della destra reazionaria per porre limiti al cambiamento sociale: è una cattiva definizione che assimila al bullismo on-line azioni collettive contro il razzismo strutturale. Lamentarsi della cultura della cancellazione, continua Bragg, non significa difendere la libertà di parola, ma innalzare uno scudo ad affermazioni incendiarie: il dibattito aperto diventa la scusa per non assumersi la responsabilità di opinioni sbagliate; che le nuove generazioni non consentono restino impunite.”
La questione, però, rimane aperta: le azioni collettive per cambiamenti sociali e sistemici a volte sfruttano indirettamente anche il bullismo e l’umiliazione pubblica nei confronti di singoli individui. In linea di principio, si tende a rigettare l’aggressione verbale a un uomo o una donna come forma di pressione; ma spesso la fermezza contro questo abuso passa in secondo piano, se l’obiettivo di una campagna è “il progresso civile”.
Le persone che hanno attaccato Mary, Raquel Sanchez, Benny Fredriksson e August Ames si consideravano parte di un movimento per abbattere il razzismo, la transfobia, le molestie sulle donne, l’omofobia.
“Ho assistito a troppi feroci abbattimenti per opinioni magari non ortodosse ma giustificabili”, ha spiegato Richard T. Ford; “o per infrazioni minori di quella che è considerata la correttezza politica.”
E’ la motivazione per cui il Professore di Stanford, studioso di diritti civili e discriminazione razziale, ha sottoscritto la “Lettera sulla Giustizia e il Dibattito Pubblico”, comparsa sulla rivista Harper’s lo scorso 7 luglio. E’ stata firmata da altri 151 intellettuali, fra cui la stessa Atwood: uomini e donne di variegata estrazione sociale, professionale, politica, culturale, etnica, religiosa, e di genere; i quali hanno condannato una tendenza affermatasi negli ultimi anni: la minaccia di ritorsioni per opinioni non conformi a istanze ideologiche o a imperativi morali; in un’atmosfera ormai “soffocante” nelle istituzioni culturali, come accademie, redazioni, associazioni. Lo scatto a svergognare qualsiasi posizione ritenuta inaccettabile da un determinato gruppo di persone – si legge nella lettera – restringe il perimetro del libero dibattito, consolidando meccanismi di censura e autocensura; l’inibizione del libero scambio di informazioni e opinioni, linfa vitale della nostra società, diminuisce la partecipazione democratica: un obiettivo a cui aspirano società intolleranti e regimi oppressivi.
Bragg descrive l’appello come una richiesta di salvaguardare uno spazio sicuro per coloro che fino a oggi sono stati gli arbitri del dibattito culturale: “gente che, prima della diffusione dei social media, veniva messa in discussione solo da intellettuali loro pari”.
La prima vera critica alla lettera non è nemmeno alla linea di pensiero esposta, ma all’idea stessa di averlo fatto: i “150 firmatari della Lettera” è assurto già a tropo negativo, come simbolo di un gruppo elitario di “vecchi” intellettuali che, in nome della libertà di parola, vorrebbero in realtà mantenere un potere egemonico sui dibattiti; in particolare, sulla politica identitaria. Come se questi 152 individui ci fossero nati in tale posizione di “privilegio”; e non se la fossero conquistata con decenni di ricerche, approfondimenti, pubblicazioni; misurandosi periodicamente con editori, consigli accademici, comitati scientifici. Conquistando lettori perfino con la censura alle calcagna, come nel caso del romanziere siriano Khaled Khalifa, o lo scrittore algerino Kamal Daoud – due dei firmatari: il primo perseguitato dal regime di Assad; sul secondo, pende una fatwa per l’impegno a una liberalizzazione sessuale nel mondo musulmano. Fra i firmatari, tra l’altro, spiccano ventenni, trentenni e quarantenni: come il promotore dell’iniziativa, lo scrittore 39enne di origine afro-americana Thomas Chatterton Williams; o come l’attivista di origine pakistana Sarah Haidar, 29enne, che ha costruito una rete di protezione nel mondo musulmano per chi vuole abbandonare l’islam; o il poeta afro-americano Reginald Betts, 40enne, fondatore di un’associazione che lotta per la riforma del sistema giudiziario minorile; o la giornalista di Seattle Katie Herzog, 35enne, ventennale attivista dei diritti della comunità LGBT+.
Nel 2017 proprio Herzog fu oggetto di una martellante campagna di “cancellazione” per un articolo apparso su Stranger in cui raccontava storie di detransizione; il pezzo era stato letto in anticipo da due transessuali, come standard di approvazione; una volta pubblicato, venne ugualmente bollato come TERF e spazzatura da prominenti attivisti per i diritti dei transessuali.
La Herzog, secondo la logica delle critiche alla lettera, farebbe parte della “vecchia classe intellettuale”; ma quale egemonia culturale poteva imporre una free-lance lesbica poco più che trentenne su una rivista di nicchia? Eppure ai “150” è imputato un marchiano fraintendimento: l’atmosfera soffocante nelle istituzioni culturali, in realtà sarebbe una nuova aria nel panorama intellettuale; attivisti, scrittori, giornalisti, accademici, che portano avanti cambiamenti della società; una trasformazione, con obiettivi radicali rispetto allo status quo, che rende il dibattito più vario.
“Pensare che la cosiddetta cultura della cancellazione sia una limitazione – scrive la scrittrice Claudia Durastanti su Internazionale – significa non cogliere i meriti dei movimenti sociali per i diritti; la lettera sembra più ossessionata e intimorita dalla gogna mediatica e dai social network, che non dal senso di giustizia nel mondo che verrà.”
L’avvocato e scrittore di origini ebree Louis Begley, un altro dei firmatari, è sopravvissuto all’Olocausto: da ragazzo sfuggì ai rastrellamenti nazisti nella natia Polonia spacciandosi per ariano.
Migliorare l’umanità, continua Durastanti, passerebbe attraverso una “decentrazione da sé”: interpretabile come una capacità di restare in silenzio a osservare che altri conducano la conversazione, ascoltarli mentre indicano una via del progresso. Via che, evidentemente, sfuggirebbe a una come Nadine Strossen – un’altra dei firmatari; dal 1991 al 2008 la Strossen è stata Presidente ACLU (American Civil Liberties Union): si è battuta contro istinti censori dell’Amministrazione Clinton per regolare internet; e ha lottato contro le politiche liberticide dell’Amministrazione Bush-Cheney. Il tema più caro alla Strossen è la libertà di opinione come diritto fondamentale di una società davvero inclusiva, al riparo da qualsiasi tipo di repressione: ancora oggi mette in guardia dal concetto di “hate speech – discorsi di odio” come termine giuridico, perché vago e sfruttabile come mezzo di censura ed esclusione.
In un simile scenario, la Strossen dovrebbe restare in silenzio mentre le viene spiegato che “cancellare” una persona per le sue opinioni, perché discutibili e detestabili, sarebbe un segno di progresso.
Oppure Richard T. Ford, che è afro-americano, farebbe meglio a non rendere pubbliche le proprie analisi sulla brutalità poliziesca sui neri; il fenomeno, per il Professore, è spiegabile solo in parte con il razzismo: perché è la disparità sociale del sistema economico, è la mentalità della punizione nel sistema giudiziario, che creano le condizioni per gli abusi e le violenze peggiori.
Per esempio Kamala Harris, Vice di Joe Biden nella corsa alla Casa Bianca, da Segretario alla Giustizia della California (2011 al 2017) ha alimentato “l’industria carceraria” con una politica di legge e ordine; particolarmente dura – e ingiusta – per la comunità afro-americana. Diventa complicato accusare di razzismo la Harris, di origine indo-afro-americana.
Invece Ford dovrebbe “passare il microfono” – espressione della Durastanti – magari a Kimberly Jones, attivista e scrittrice afroamericana emersa dopo i fatti di Ferguson 2014, quando un poliziotto uccise Michael Brown, facendo esplodere il movimento Black Lives Matter (BLM). In un discorso virale, ispirato dall’assassinio di George Floyd, la Jones ha denunciato la rottura del contratto sociale negli Stati Uniti, dove gli afroamericani vengono uccisi proprio da chi è deputato a difenderlo, quel contratto. Una situazione esasperante, tanto che l’attivista si chiede – sullo sfondo della scritta “Acab”, tutti i poliziotti sono bastardi – se abbia senso onorare la convivenza civica; ecco la parte finale del video, girato lo scorso 31 maggio, e rimbalzato per le emittenti di tutto il mondo:
“Avete rotto il contratto uccidendoci per le strade senza che ve ne fregasse niente; lo avete rotto per 400 anni: noi abbiamo fatto il vostro gioco costruendo [sotto schiavitù] la vostra fortuna. Voi avete rotto il contratto quando abbiamo costruito la nostra, di fortuna, a Tulsa, e voi ci avete bombardato [ndr: la distruzione di Greenwood, Tulsa, la Wall Street nera, nel 1921]. Avete rotto il contratto; quindi si fotta il vostro Target, si fotta il vostro Hall of Fame. Per quanto mi riguarda, possono radere al suolo tutto questo schifo, e ancora non sarebbe abbastanza. E sono fortunati che noi neri stiamo cercando pari opportunità e non vendetta.”
Target e Hall of Fame sono edifici di Atlanta saccheggiati e dati alle fiamme durante le proteste dello scorso maggio. Per giorni, in molte città americane, con la scusa delle manifestazioni, gruppi di persone hanno assaltato negozi e distrutto proprietà. Chi denunciava quella situazione, è stato attaccato come “parte del problema”: non si può mettere sullo stesso piano la vita di un uomo con il valore di un immobile o di mera merce. Un’equazione che però esclude la violenza come fattore di rischio per l’incolumità sia dei manifestanti, che dei poliziotti.
A St. Louis, non lontano da Ferguson, l’afro-americano David Dorn, ex agente di polizia in pensione, è stato ammazzato mentre cercava di bloccare un saccheggiatore. Proprio ad Atlanta, lo scorso 4 luglio una bambina di 8 anni, Secoriea Turner, afro-americana come Jones, è stata uccisa con un colpo di pistola mentre la madre guidava nei pressi di un picchetto di manifestanti; un giovane afro-americano è accusato di questo omicidio.
Condivisibile in varie parti, il discorso della Jones ha però sdoganato la violenza delinquenziale per le strade di Atlanta; eppure ha riscosso vasta ammirazione. All’opposto ha provocato un putiferio l’opinione sul New York Times a firma del senatore repubblicano Tom Cotton, che invocava il dispiego di truppe federali nelle aree dove la polizia non riesce a limitare vandali e saccheggiatori. Il responsabile della sezione opinioni del New York Times, James Bennett, è stato costretto alle dimissioni; aveva ammesso errori nell’editing del pezzo, difendendo però la scelta su Twitter: il giornale non fa parte dell’opposizione, deve offrire contro-argomentazioni anche dolorose, ma che rappresentano punti di vista tutt’altro che isolati; soprattutto se a esprimerli è un politico che può incidere sul processo decisionale.
Il Senatore Cotton, laureato in Legge ad Harvard, aveva offerto basi legali e precedenti storici per motivare la sua posizione; pur condannando la brutalità poliziesca sugli afro-americani, e concedendo la legittimità di pacifiche proteste.
Del resto truppe federali sono state inviate a Portland, dove i manifestanti anarchici avevano occupato un’area residenziale; dopo settimane di teso confronto, le truppe hanno lasciato la città, ma la polizia di Portland ancora oggi denuncia il clima di rivolta per le strade, con attacchi quotidiani a edifici statali e federali, ed esercizi privati. E’ da due mesi che si parla di invio di truppe federali a Chicago, dove intere zone sono in mano a bande e saccheggiatori, come denunciato da vari consiglieri comunali; il tasso di omicidi a luglio è aumentato del 139% su base annua.
Ecco alcune delle risposte più “cuorate” alla chiarificazione di Bennet: “Taci viscido”; “Scusati”. Tuttavia è stata la protesta interna alla redazione del New York Times che non gli ha lasciato scampo: “Pubblicare questo [l’opinione di Cotton] mette in pericolo lo staff di colore del New York Times“, è stata l’accusa dei colleghi; per lui non c’è più stata una vera chance di mantenere la posizione.
Matteo Pascoletti su ValigiaBlu, nota un probabile riferimento al caso di Bennet nella lettera di Harper’s – da lui definita “fuori dalla realtà”; e si chiede dove sia lo scandalo per quel tipo di sollevamento nella redazione del New York Times: perché Cotton, che incita all’odio, avrebbe diritto di parola, e non dovrebbe averla un redattore di colore del New York Times, minacciato da quell’odio?
Per il secolare Neue Zürcher Zeitung, quotidiano svizzero conservatore, riconosciuto per l’oggettività, l’esautorazione su due piedi di Bennet rappresenta un campanello d’allarme: il pensiero critico nelle redazioni, rischia di essere sostituito dal “pensiero morale”.
David Roberts su Vox, ha smontato il pezzo di Cotton attraverso una minuziosa contro-argomentazione; fra tutte, le prove che spesso è stata la polizia a scatenare le violenze attaccando i manifestanti. Poi però aggiunge: è giusto mettere all’indice l’oped di Cotton – e il far fuori Bennet – perché sarebbe stato necessario marcare una linea di decenza morale.
Pascoletti spiega meglio questo principio con l’intolleranza costitutiva; cioè “in una società, in un dato momento, noi sappiamo rendere talune opinioni o argomenti sconvenienti – o persino illegali.”
Questo principio non contraddirebbe la lettera di Harper’s: perché un conto è raggiungere uno stadio di intolleranza costitutiva nella società dopo un percorso politico-sociale-culturale; un altro è imporre la propria idea usando il metro dell’intolleranza verso l’altro. Nel primo caso si parla di un’obiettivo della lotta politica; nel secondo, di un metodo.
L’ex Direttore editoriale di The Nation e attuale Direttore esecutivo dell’HuffPost Richard Kim ha rigettato l’offerta di firmare la lettera, ridicolizzandone contenuti e obiettivi.Dopo qualche giorno, però, ha specificato: spesso si affacciano richieste censorie e radicate nell’intolleranza; a cui a volte decidiamo di sottostare, salvo rimpianti. Kim critica comunque l’intento della lettera: non perché i meccanismi di censura e auto-censura non esistano nelle redazioni; ma perché i 150 fingono che siano emersi recentemente con la cultura della cancellazione.
Al di là dell’auto-referenza al mondo giornalistico, a Kim sembra sfuggire un punto cruciale della lettera: il dibattito all’interno di una redazione può anche essere influenzato da richieste censorie, da valutare e magari accogliere; ma non può rischiare di esserne dominato: perché altrimenti si ingrana “quell’intolleranza alle differenze in favore di un conformismo ideologico” di cui si parla nella lettera di Harper’s. Fenomeno ben diverso dall’intolleranza costitutiva avanzata da Pascoletti.
Sul pezzo di Valigia Blu si fanno nomi e cognomi di altri casi che nella lettera vengono generalizzati; una volta indagati, svuoterebbero di credibilità l’intento dei “150”. Infatti, come ricostruisce l’autore, sono altri i veri problemi relativi alla libertà di parola: a partire dalla scarsa rappresentanza delle minoranze nel dibattito pubblico; o l’estromissione di tutte quelle voci designate come “terroriste” dal Dipartimento di Stato Usa; la soppressione delle voci pro-palestinesi nei campus universitari; l’iniquità riservata alla comunità LGBT+; il giro di vite contro i dissidenti egiziani; la cancellazione della storia siriana da youtube; la mancata denuncia del ricorso all’Espionage Act contro Julian Assange.
E’ legittima l’idea che un appello di denuncia su un generale clima di erosione della libertà di parola debba contemplare anche queste variabili; ma allora va ricordato che proprio Harper’s, nell’agosto 2014, pubblicò un durissimo pezzo su Al Sisi e la restaurazione della dittatura in Egitto. Scorrendo i firmatari della lettera, poi, si notano Hussein Ibish, analista dell’Arab Gulf State Institute, che per anni si è speso per l’indipendenza della Palestina attraverso l’American Task Force on Palestine. O Zephyr Teachout, Professoressa di Legge e candidata governatrice di New York State, la quale ha contestato l’arresto di Julian Assange: alla sorte del fondatore di Wikileaks, ha twittato, è legata la libertà di stampa negli Usa.
In generale, fra chi sposa i contenuti della lettera, si conta la presenza di decine di persone che da una vita si battono per i diritti civili delle minoranze su base etnica, religiosa, politica, e di genere. Ad esempio Loretta J. Ross, campionessa della giustizia riproduttiva, in particolare fra le donne afro-americane. Fra loro c’è anche la transdonna Jennifer Finney Boylan; che però si è detta pentita dell’appoggio all’iniziativa: non sapeva della presenza della best-seller britannica Joanne K. Rowling tra i firmatari. La Rowling, da un paio d’anni, è accusata di transfobia per la sua difesa dei diritti delle donne su base biologica.
Un’altra figura controversa è David Frum, editorialista di The Atlantic, e uno dei propagandisti della Guerra al Terrore dell’Amministrazione Bush-Cheney. Negli anni Frum ha ammesso che l’invasione dell’Iraq nel 2003 fu un disastro, mettendo in guardia da un intervento Usa in Iran; oggi è uno dei più influenti critici del Presidente Usa Donald Trump. La stessa Rowling è stata un punto di riferimento per i detrattori dell’ex leader laburista Jeremy Corbyn, socialista con posizioni considerate radicali.
Se il passato di Frum, le convinzioni polarizzanti della Rowling, o le contraddizioni di qualche altro firmatario, bastano a invalidare la caleidoscopica esperienza di 152 fra scrittori, giornalisti, accademici e attivisti, allora – come si legge nella lettera – significa che davvero è un periodo in cui le istituzioni culturali sono messe alla prova.
“Abbiamo bisogno di una cultura che ci lasci spazio per la sperimentazione, per il prendersi dei rischi, anche per fare degli errori. Dobbiamo mantenere la possibilità di un disaccordo in buona fede senza devastanti conseguenze sul piano professionale.”
E anche sul piano umano, viene da aggiungere; e non solo per chi si occupa di cultura. Le lacrime di Mary, su Youtube, mentre raccontava delle minacce subite per una opinione legittima, erano una realtà.
di Cristiano Arienti
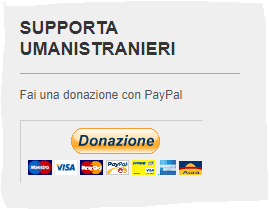
In copertina: Colors of Liberty – by Ed Kobra

Fonti e link utili
https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8503283/amp/The-trans-lobby-bully-silence.html (Raquel Rosario Sanchez)
https://medium.com/@mary.leng/harry-potter-and-the-reverse-voltaire-4c7f3a07241
https://www.bristolpost.co.uk/news/bristol-news/bristol-university-accused-targeting-transgender-1622246 (sulla questione Sanchez)
https://www.npr.org/2018/10/31/662178315/on-metoo-americans-more-divided-by-party-than-gender
https://adaa.org/learn-from-us/from-the-experts/blog-posts/consumer/metoo-latest-ocd-trigger
https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/05/the-meaning-of-nakba-israel-palestine-1948-gaza/560294/ (Hussein Ibish sulla Palestina)
Dossier BalcaniCaucaso.org sull’Hate Speech
https://www.hd.se/2019-03-11/ratt-att-aftonbladet-falls-for-granskningen-av-benny (sulla criminalizzazione di Benny Fredriksson)
